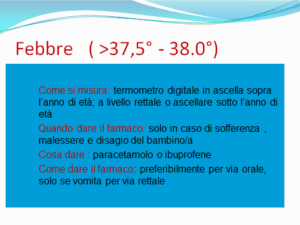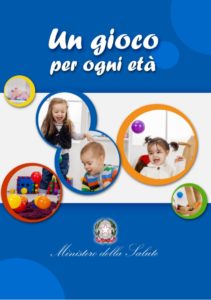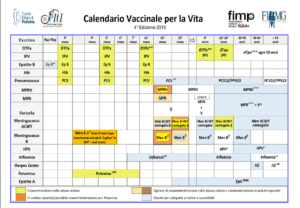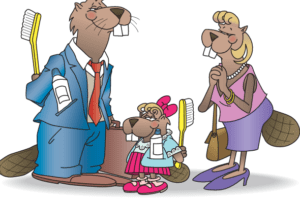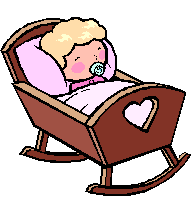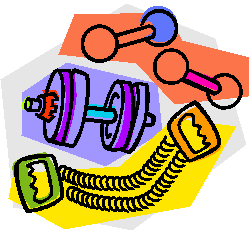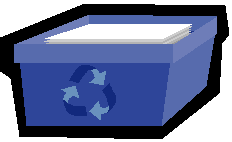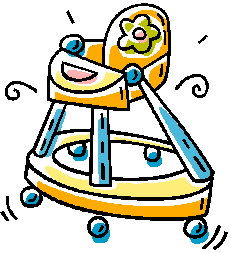Primo Soccorso e Informazioni
Un servizio che ti permette di risolvere dubbi e preoccupazioni sulla salute tua e dei tuoi familiari.
Non sostituisce in nessun caso il parere del medico e non è un’alternativa al servizio pubblico del SSN, ma viene in tuo supporto quando questo non è disponibile con l’obiettivo di rafforzare la medicina di base in maniera facile e accessibile per tutti, in accordo con le Linee di Indirizzo Nazionali in materia di Telemedicina.Fonti e approfondimenti:
Ministero della Salute – https://www.salute.gov.it/
Società Italiana Pediatria – https://sip.it/
lo sport fa bene:

Fino a 5 anni:
favorire l’attività motoria , soprattutto all’aria aperta, dando il buon esempio e incoraggiando i bambini con varie attività ( soffiare bolle di sapone, giocare a guardia e ladri, ruba bandiera per migliorare la capacità polmonare; il salto con la corda irrobustisce l’arco plantare ed aiuta a correggere il piede piatto; il triciclo corregge il ginocchio valgo; la danza e la ginnastica artistica possono aiutare la gestualità corporea e l’orientamento spaziale. E’ consigliabile una attività motoria per almeno 30 minuti al giorno.
Alle “Elementari”:
lo sport è soprattutto gioco ed è bene che ci sia possibilità di sperimentare vari sport ed accrescere il proprio bagaglio neuro-psicomotorio. E’ importante far sempre “provare” prima della scelta.
Alle “Medie”:
optare per uno sport in cui ci si riconosca come gruppo e ci si possa mettere alla prova.
In base al carattere del bambino si potrebbe consigliare
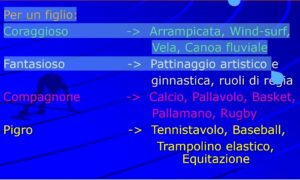
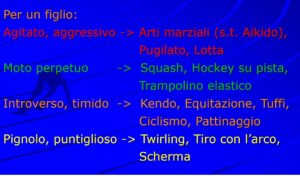
Lo sport migliora anche il rendimento scolastico
- facilita la crescita cognitiva passando dall’intelligenza sensomotoria a quella ideomotoria
- migliora l’autostima
- si esercita la memoria
- si sviluppa l’attidudine alla concentrazione
- si aumenta il controllo delle emozioni
- si migliorano le capacità di attenzione
- si fanno meno assenze per malattia
I diritti dello sportivo
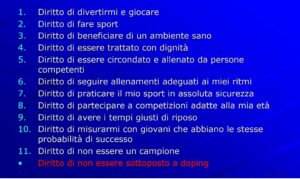
Ecco una piccola tabella degli sport più diffusi

Per la compilazione dei consigli ci siamo avvalsi del libro : Lo sport che fa bene al tuo bambino di Carlo Napolitano
Da alcuni mesi, anche da noi, è in corso una epidemia infettiva da Streptococco beta emolitico di Gruppo A. Questo germe è un batterio responsabile di faringotonsillite acuta, scarlattina ed altre malattie.
Quando rivolgersi al proprio Pediatra?
Se il bambino ha questi sintomi: febbre, “mal di gola”, ingrossamento dei linfonodi del collo, difficoltà ad ingoiare.
Quando eseguire un tampone faringeo?
E’ il Pediatra che decide l’esecuzione del tampone in caso di sospetto clinico.
Quando non eseguire il tampone faringeo?
a) al termine della terapia antibiotica, che deve essere scrupolosamente effettuata secondo le indicazioni del Pediatra.
b) in caso di contatti( comunità scolastica, famiglia) in assenza dei sintomi sopra descritti
c) in caso di rinite, tosse, congiuntivite
Quando il bambino può rientrare a scuola?
Dopo 24-48 dall’inizio della terapia antibiotica il bambino non è più contagioso ma il rientro a scuola è subordinato al recupero del completo benessere.
Occorre il certificato medico per il rientro a scuola?
Solo in caso di scarlattina.
Indicazioni, divise per fascia di età dei vostri bambini. Leggetele, mettetele in pratica, e i media diventeranno vostri alleati nella crescita dei vostri figli e nell’aumento del loro benessere.
Estratto dal sito : https://www.custodidigitali.it/
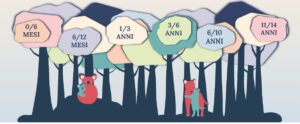
——————————————————————————————————————————————————
0 – 6 mesi
Guarda il tuo bambino
Non farti distrarre da messaggi o notifiche: quando il bambino è sveglio togli la suoneria al telefono-Cerca di usarlo quando il bambino dorme.
Allatta il tuo bambino senza schermi
l’allattamento è un momento fondamentale di relazione. Evita di usare schermi ( tv o smartphone). Non lo stai solo nutrendo , stai creando un legame fondamentale per il suo benessere.
Il pianto del bambino è un messaggio per te.
Impara a capire ed interpretare il pianto del tuo bambino, anche se a volte sarà faticoso. Ricorda che utilizzare lo smartphone per distrarre il bambino non aiuta ye e soprattutto non aiuta il tuo bambino ad autoregolarsi. Lo schermo ipnotizza il suo sguardo , non lo farà stare meglio.
Resta connesso e social
Continua ad utilizzare internet ed i social media, ma lontano dallo sguardo del bambino.Quando condividi le foto di minori sui social ricorda di rispettare la loro privacy: dalla rete non si cancella nulla
——————————————————————————————————————————————————
6-12 mesi
MANGIARE È UNA SCOPERTA CONTINUA
Ogni volta che metti il tuo bambino davanti ad uno schermo gli impedisci di muoversi: quindi di imparare qualcosa.
Lascia al bambino la libertà di muoversi e di giocare e sperimentare, sempre sotto il tuo sguardo. Incoraggia la sua curiosità verso gli oggetti e strumenti che producono suoni.
IL TUO BAMBINO IMPARA MUOVENDOSI
Il bambino si muove e impara a stare seduto senza appoggio: lascia al bambino la libertà di muoversi ed esplorare, di afferrare oggetti, sempre sotto il tuo sguardo. Visto che l’intelligenza si sviluppa con il movimento evita di mettergli davanti uno schermo appena riesce a stare seduto. Osserva cosa fa con gli oggetti, come si rapporta con il mondo e che tipo di interesse manifesta
AIUTA IL TUO BAMBINO AD AUTOREGOLARSI
Non avere paura del pianto del bambino, anche se in certi momenti ti provoca ansia e dubbi, e resisti alla tentazione di mettergli davanti uno schermo per farlo smettere di piangere.
Tre cose aiutano il bambino: la voce, il contatto fisico, il movimento. In questo modo può essere consolato un bambino.
FUORI CASA GUARDA IL MONDO
Quando porti il tuo bambino a fare un giro con il passeggino, digli di guardare tutto quello che ha intorno a sé. Porta un oggetto che possa mordere o un piccolo libro che possa tenere in mano, ma non dagli in mano uno schermo. Quando puoi, racconta quello che sta vedendo.
LEGGI E RACCONTA STORIE
La voce (della mamma e del papà) è un calmante naturare e le storie hanno sempre un potere magico. Per i video ci sarà tempo. Cantare per il bambino: la musica è sempre un dono!
—— ————————————————————————————————————————————————
1- 3 anni
IL MOVIMENTO SVILUPPA IL CERVELLO
Ogni volta che metti il tuo bambino davanti ad uno schermo gli impedisci di muoversi: quindi di imparare qualcosa.
Lascia al bambino la libertà di muoversi e di giocare e sperimentare, sempre sotto il tuo sguardo. Incoraggia la sua curiosità verso gli oggetti e strumenti che producono suoni.
A TAVOLA SI STA INSIEME E SI PARLA
Durante i pasti gli schermi restano spenti, compresi i telefoni di mamma e papà e la tv.
ARRIVANO I PRIMI VIDEO E CARTONI ANIMATI
Dai due anni puoi introdurre i primi cartoni animati: guarda sempre in anticipo di programmi e fai attenzione alle indicazioni di età.
ASCOLTA MUSICA
Ascolta musica e canta insieme al tuo bambino. Cogli ogni occasione di partecipazione ad eventi di musica dal vivo.
LEGGI AL TUO BAMBINO
Le storie lette dalla voce del genitore hanno una magia diversa rispetto ai video, alla tv o alle voci artificiali
degli assistenti vocali.
PROTEGGI IL SONNO DEL TUO BAMBINO
Tv e tablet restano fuori della cameretta del bambino:
dormire bene è fondamentale per il suo benessere,
almeno 10/12 ore per notte.
—————————————————————————————————————————————————–
3 – 6 anni
GLI SCHERMI POSSONO ASPETTARE
In questa fase è fondamentale il gioco e la sperimentazione diretta. Se decidi di usare un tablet limita il tempo e scegli bene i contenuti. Non usarlo durante i pasti.
DECIDI I TEMPI DI UTILIZZO
Video, tv e schermi devono avere dei tempi stabiliti da mamma e papà – anche diversi durante la settimana e nel fine settimana – e non devono superare 2 ore al giorno.
A TAVOLA SI STA INSIEME
Durante i pasti gli schermi restano spenti, compresi i telefoni di mamma e papà e la tv. Il cibo non è solo nutrimento, è relazione e intimità.
CHIEDI CHE COSA HA VISTO
Chiedi sempre al tuo bambino di raccontarti quello che ha visto: lo aiuterai a capire meglio e anche tu potrai comprendere quello che ha capito del video e della storia che ha visto.
RISPETTA LE ETÀ CONSIGLIATE
Cartoni animati e programmi televisivi hanno indicazioni di età e anche le app e app e i videogiochi (lo standard PEGI).
QUANDO USI I MEDIA, FALLO CON CREATIVITÀ
Lo smartphone è un registratore, una macchina fotografica, una videocamera. Lo puoi usare come strumento per fare cose bellissime insieme al tuo bambino (come si usano carta e colori per fare disegni o forme). Ascolta musica e canta insieme al tuo bambino.
CONTINUA A LEGGERE AL TUO BAMBINO
Le storie lette dalla voce di mamma e papà hanno una magia diversa rispetto ai video, alla tv o alle voci artificiali degli assistenti vocali.
PROTEGGI IL SONNO DEL TUO BAMBINO
Tv e tablet restano fuori della cameretta del tuo bambino. Dormire bene è fondamentale per il suo benessere, almeno 10 ore ogni notte.
——————————————————————————————————————————————————-
6-10 anni
LO SMARTPHONE NON È OBBLIGATORIO
I bambini a questa età hanno sempre un adulto vicino; non serve loro uno smartphone né per la sicurezza né
per stare con i loro amici. Meglio più avanti.
Sui tuoi dispositivi metti una password.
I VIDEOGIOCHI NON SONO TUTTI UGUALI
Molto spesso i videogiochi “popolari” tra i bambini non hanno contenuti adatti alla loro età. Controlla lo standard PEGI e chiedi al tuo pediatra l’elenco dei videogiochi adatti alle diverse età.
INTERNET È FATTO PER GLI ADULTI
Se non vuoi che tuo figlio veda contenuti pornografici o violenti, devi sempre controllare e sapere quando va su internet. Metti un parental control sui dispositivi digitali e chiedi la relativa scheda al pediatra.
USA I MEDIA CON CREATIVITÀ
Lo smartphone è un registratore, una macchina fotografica, una videocamera. Lo puoi usare come strumento per fare cose bellissime insieme al tuo bambino, come si usano carta e colori per fare disegni o forme.
CHIEDI CHE COSA HA VISTO
Chiedi sempre al tuo bambino di raccontarti quello che ha visto: lo aiuterai a capire meglio e anche tu potrai comprendere quello che ha capito del video e della storia che ha visto.
PROTEGGI IL SONNO DEL TUO BAMBINO
Lascia tv, smartphone e video fuori della stanza da letto del bambino. Ricorda che almeno 9/10 ore di sonno sono fondamentali per il suo benessere
——————————————————————————————————————————————————-
11 – 14 anni
DECIDI INSIEME LE REGOLE DI UTILIZZO
Metti delle regole chiare per l’utilizzo dello smartphone e dei Social Media. Chiedi al tuo pediatra “il contratto” per l’utilizzo dello smartphone che può essere un buon punto di partenza.
LO SMARTPHONE DEVE STARE FUORI DELLA CAMERA DA LETTO
Decidi un posto della casa dove mettere i dispositivi prima di andare a dormire e dai l’esempio mettendo anche il tuo. Torna ad utilizzare la buona vecchia sveglia. Dare il buon esempio è fondamentale.
TRASPARENTE FINO A 14 ANNI
La password di qualsiasi dispositivo deve essere comunicata ai genitori che hanno l’obbligo legale di controllare i social media e le attività online. L’obbligo del controllo prevale sulla privacy.
CONTROLLA SOCIAL, APP E VIDEOGIOCHI
Una foto sui social, anche mandata per scherzo, in un solo giorno può raggiungere migliaia di persone. Se fosse quella di tuo figlio o di tua figlia vorresti averla fermata in tempo. Metti la regola che videogiochi e app si scaricano assieme.
CHIEDI QUELLO CHE SUCCEDE ON LINE
Quello che avviene sui social e in rete è importante
per tuo figlio tanto quanto un’esperienza reale.
Quindi interessati sempre di quello che fa on line e lo coinvolge, videogiochi e social media compresi.
Ecco le regole da appendere nella camera dei papà
- Smettiamo di riempire di regali i nostri figli. Il consumismo fa scomparire il desiderio e apre le porte alla noia.
- Quello che conta è l’intensità, ma non trascuriamo anche la quantità di tempo passato con i bambini. La prima mezz’ora del rientro a casa dal lavoro è fondamentale. Deve essere dedicata al colloquio e alle coccole. E non certo a chiedere dei compiti o dei risultati.
- I giochi più educativi sono quelli che passano attraverso la fantasia della madre e le mani del padre: basterebbero due pezzi di legno ma i genitori ormai non sanno più inventare. I giochi complicati e tecnologici non possono essere definiti “giochi”.
- Dai tre ai cinque anni è bene avviare i bimbi ai lavoretti di casa, assieme ai genitori. È utile che sappiano stirare con un piccolo ferro, attaccare un bottone, piantare un chiodo, pulire un’aiuola.
- Sport: prima di tutto deve essere vostro figlio a desiderarlo. Meglio in gruppo, facendogli capire che agonismo significa emergere con fatica e non solo diventare campioni. Ottime due o tre ore di palestra alla settimana. Poca competizione, tanto beneficio fisico. Tenete sempre in evidenza le due tipologie: sport di squadra e sport individuale.
- Va incoraggiata la cultura artistica, abituando i bambini al bello. Teatro, musica, arti visive regalano il desiderio di migliorare. I soldi spesi per la cultura sono quelli che rendono di più.
- Mettiamo un salvadanaio sulla credenza della cucina. Ogni giorno facciamo inserire alcuni soldini per sostenere le famiglie povere e i bambini orfani.
- Fate imparare ai bambini, fin dai primi anni, nel modo più simpatico e meno scolastico possibile, una lingua. Servirà loro per girare e per scoprire precocemente le tradizioni, le abitudini, le culture e le storie del resto del mondo.
- Usate una settimana di ferie per vivere insieme un’avventura forte, scioccante, affascinante, rischiosa, internazionale (appena si potrà fare).
- Insistiamo in tutti i modi perché gli orari di lavoro siano elastici sia per i genitori che hanno bambini piccoli in casa e sia per i genitori che hanno adolescenti più o meno problematici. La presenza dei genitori in questi due periodi è più che mai invocata.
Tratto da “Diamo Gambe al cervello” di don Antonio Mazzi Edizioni Sanpino, 2023
Uno dei momenti più attesi ed emozionanti per i neo genitori è quando il loro bambino comincia a muovere i primi passi. Spesso, però, questa fase è accompagnata da dubbi e preoccupazioni. Piedi piatti, gambe a X (ginocchio valgo) o gambe “da fantino” (ginocchio varo) sono visti come difetti, quando invece rappresentano una fase normale dello sviluppo fisiologico di ogni bambino. La valutazione completa del neonato nei suoi primi giorni di vita e l’esecuzione di un’ecografia delle anche consentono di tranquillizzare mamme e papà e di diagnosticare precocemente eventuali patologie.
LE ANCHE
Ecografia alle anche: perché e quando va eseguita
L’ecografia alle anche è un esame molto importante, perché permette di diagnosticare e trattare precocemente la displasia evolutiva dell’anca, più nota come lussazione dell’anca. Si tratta di un’anomalia dell’articolazione coxofemorale che, se non curata, può compromettere la corretta deambulazione futura del neonato.
L’indicazione attuale è quella di effettuare l’ecografia non solo ai pazienti a cui fosse diagnosticata la presunta lussazione dell’anca, dalla cosiddetta manovra di Ortolani-Barlow, una prova fatta dal neonatologo nei primi giorni di vita del bambino, ma a tutti . Anche se non rientra nello screening neonatale obbligatorio, il consiglio è di fare sempre l’ecografia delle anche il prima possibile, quando il processo di ossificazione della testa femorale non è ancora completato.
SCREENING ECOGRAFICO
ANCHE A RISCHIO: alla nascita
IL RESTO: a 4-6 settimane perché:
– si riducono a quest’età i controlli ecografici ed i trattamenti superflui
– in assenza di segni clinici e di fattori di rischio può comunque esserci displasia
– in caso di displasia grave si può comunque ancora attuare un trattamento precoce, in un’età in cui il potenziale di guarigione dell’anca è ancora molto elevato
I PIEDI
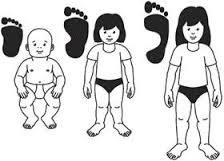
Quali alterazioni sono da considerare evoluzioni fisiologiche del bambino?
Nel bambino il piede piatto è un fattore quasi sempre fisiologico. Durante lo sviluppo la sua conformazione si modifica e intorno ai dieci-dodici anni diventerà quella definitiva. Quando il bambino inizia a camminare si noteranno le ginocchia in fuori o “da fantino” (ginocchio varo) che, verso i due-tre anni, diventeranno a X (ginocchio valgo). Intorno ai cinque anni le ginocchia si raddrizzeranno e assumeranno la forma definitiva dell’adulto.
A piedi nudi o con scarpe “rinforzate”?
Camminare a piedi nudi in casa fa bene soprattutto ai bambini molto piccoli, poiché stimola le articolazioni del piede e lo sviluppo osseo e il piccolo impara a mantenere l’equilibrio su terreni lisci. Gli effetti maggiori per il piede si ottengono camminando su terreni sconnessi come la spiaggia del mare, vera e propria ginnastica plantare contro il piattismo.
LA CALZATURA DEL BAMBINO
Componenti della scarpa:
Le principali componenti della calzatura sono la parte superiore, la suola, la parte esterna ed il retropiede.
La parte superiore della scarpa copre il dorso e le parti laterali del piede ed è attaccata alla suola. La sue principali componenti sono la tomaia, il quarto, la zona dei lacci, la linguetta, la gola, la zona di contenzione del calcagno e quella delle dita.
La scarpa del bambino che inizia a camminare
Un bambino con un piede normale non necessita di calzatura finché non incomincia a camminare. Fino a tale momento è sufficiente una calzatura che mantenga caldo il piede.
La calzatura del bambino che incomincia la deambulazione dovrebbe rispettare i seguenti criteri:
- la suola deve essere flessibile (né troppo rigida né troppo morbida) in modo tale da permettere un passo sicuro, favorire la stabilità e la spinta durante il cammino.
- la parte superiore della scarpa (tomaia) deve essere soffice e flessibile in modo tale da assecondare i movimenti del piede e così da evitare irritazioni a carico della delicata pelle del piede del bambino.
- la zona delle dita dei piedi deve essere sufficientemente capiente in modo da permettere i movimenti delle dita stesse .Questo va verificato con il bambino in piedi, lo spazio per le dita deve esserci sopra e davanti.
- la calzatura deve essere sufficientemente alta da riuscire a dare stabilità alla caviglia
- i fori per i lacci devono essere numerosi perché questo aumenta la stabilità del piede nella scarpa
- la linguetta deve essere soffice.
- il plantare deve avere un normale, soffice sostegno della volta (NON PLANTARI CORRETTIVI).
- il tacco deve essere di altezza media .
Attenzione deve essere posta nel mettere le scarpe al bambino. Spesso i bambini riescono a sopportare anche grossi disagi e mentre infilano le scarpe sovente piegano le dita o mettono il piede in modo inappropriato.
I genitori possono controllare se le scarpe vengono indossate nel modo giusto; un metodo consiste nel togliere ,una volta a casa, rapidamente le scarpe e le calze ed osservare se ci sono segni di irritazione o arrossamento a livello delle dita e del piede.
Attenzione anche ad evitare pieghe delle calze e pinzettamenti della pelle a livello della linguetta della scarpa.
I lacci devono essere posti in una giusta tensione partendo dal basso e venendo verso l’alto, tirando gradatamente e progressivamente.
Quando non usate, le scarpe dovrebbero essere conservate con le apposite forme o con pezzi di carta in modo tale da mantenere la struttura per lungo tempo.
Una calzatura che provoca irritazioni e dolori a carico del piede deve essere immediatamente eliminata perché la pelle del piede del bambino è particolarmente delicata e guarisce con difficoltà ed inoltre influisce negativamente sul futuro atteggiamento del bambino nei confronti delle calzature.
TUTTE LE CALZATURE CORRETTIVE NON DEVONO VENIRE UTILIZZATE FINO A CHE IL BAMBINO NON CAMMINA CON SUFFICIENTE SICUREZZA (IN MEDIA CIRCA 4 MESI DALL’ INIZIO DELLA DEAMBULAZIONE) E ANCHE DOPO TALE PERIODO SOLO SU PRECISA PRESCRIZIONE DA PARTE DEL MEDICO SPECIALISTA.
Attenzione va posta alla crescita del piede e di conseguenza al cambio di misura della calzatura, proponiamo la seguente tabella indicata dalla Società Ortopedica Americana del Piede
| ETA’ DEL BAMBINO (IN MESI) * FREQUENZA CONSIGLIATA DI CONTROLLO
______________________________________________________________________ |
12-17………………………………………………………………..OGNI 2 MESI
18-29………………………………………………………………..OGNI 3 MESI
30-47………………………………………………………………..OGNI 4 MESI
48-71………………………………………………………………..OGNI 6 MESI
__________________________________________________
Un consiglio molto importante: evitate di far indossare a vostro figlio calzature già utilizzate da fratelli o cuginetti, innanzitutto perché la scarpa deve essere personale e adatta alla conformazione del piede; inoltre, quella già usata è deformata e, quindi, potrebbe portare a una postura e a una camminata non corretta.
LA CALZATURA PER IL BAMBINO IN ETA’ SCOLARE
Quando il bambino raggiunge l’età per andare a scuola vari fattori possono creare dei problemi:
dai 6 ai 9 anni il bambino entra in un periodo di crescita molto importante e le scarpe possono diventare rapidamente strette.
in questa fase della sua vita viene in contatto con altri suoi coetanei ed inoltre prende progressivamente coscienza dei suoi gusti ed incomincia a desiderare le scarpe che ha visto ai suoi amici/amiche.
Le scarpe in età scolare dovrebbero essere robuste ma con una suola flessibile, sufficientemente comode, preferibilmente allacciate, con lunghi lacci, con una zona per le dita ampia.
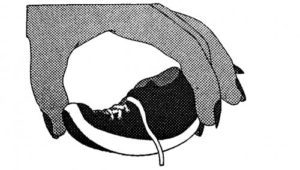
E’ questa l’età in cui nasce il desiderio di possedere più di un paio di scarpe al fine di soddisfare esigenze estetiche ,di gusto personale e/o sportive.
Non è consigliabile proibire quelle che sono delle giuste aspirazioni dei ragazzi, ma è meglio limitare l’uso di queste calzature al loro utilizzo specifico (ad esempio scarpe da pallacanestro solo nelle ore della effettiva pratica della disciplina sportiva).
Le buone scarpe non devono necessariamente essere costose.
IL PIEDE PIATTO: MA E’ PROPRIO UNA PATOLOGIA DA TRATTARE ?
Incominciamo a “smontare” un luogo comune: il termine piede piatto non significa assolutamente nulla.
Non è l’identificazione di una patologia ma la descrizione di un aspetto.
Con il termine “valgismo del retropiede” ci si riferisce al fatto che il calcagno tenda a portarsi verso l’ esterno quando il soggetto è in piedi ma questo non è un dato patologico ma descrittivo.

Con il termine “pronazione del piede” si intende il piede che ruota verso l’ esterno.

Queste situazioni sono state descritte come problematiche che determinano problemi immediati o futuri al piede.
Ciò non è assolutamente vero; e la loro correzione, che avvengano o meno nel corso della crescita, non preserveranno da dolori o disturbi né si rifletteranno su anche, ginocchia, colonna vertebrale, etc.
Nel bambino che inizia a camminare il piede si presenta ESTETICAMENTE PIATTO per definizione: è dovuto ad un deposito di grasso presente nell’ arco plantare che determina questo aspetto evidente esteticamente.
I genitori sono giustamente preoccupati spesso perché a loro volta hanno avuto un trattamento per i propri piedi durante la loro infanzia.
I nonni dei bambini hanno fatto trattare i loro figli per tale problema e spingono affinché i loro nipoti vengano curati per la stessa problematica per cui loro hanno curato i figli. Sono tutti convinti che il miglioramento del piede è stato ottenuto grazie al trattamento a cui sono stati sottoposti e ora vorrebbero che lo stesso avvenisse per il bambino, se possibile anche in modo più rapido e con metodi più efficaci, ritenendo utili l’applicazione di plantari e calzature ortopediche.
La nascita di calzature ortopediche e solette correttive è avvenuta in Europa ed il loro utilizzo è ancora largamente diffuso.
I plantari sono come gli occhiali: appena tolti, il difetto si manifesta nuovamente. I plantari NON correggono
I plantari Sostengono
Calzature correttive alte e rigide? Nel tempo è sempre la scarpa a modellarsi sulla forma del piede e MAI il contrario
OLTRE IL 90% DEI CASI NON NECESSITA DI TRATTAMENTO
Il plantare non modifica lo sviluppo del piede piatto;se il piede è piatto, resta piatto anche dopo anni di diligente
correzione con il sostegno di una ortesi plantare
in conclusione il piede piatto
FINO AI 4 ANNI: è considerato una fase dello sviluppo ontogenetico del piede
DOPO I 4 ANNI: fisiologico? (morfologico)
patologico? (morfologico e funzionale)
asintomatico?
sintomatico?
Pertanto se persiste dopo i 4 anni sarà il vostro pediatra a valutare la necessità o meno di una visita specialistica
CAMMINA SULLA PUNTA DEI PIEDI
L’andatura in punta di piedi nel periodo che va da uno a due anni compiuti è da considerarsi un normale meccanismo di potenziamento della muscolatura antigravitaria ed un’utile fase di passaggio nello sviluppo psicomotorio per raggiungere la corretta esecuzione del passo e della corsa. Dopo i due anni si ritiene sia causata da un’eccessiva tensione di un muscolo del polpaccio (il tricipite della sura) e del tendine di Achille. Lo si può notare perché, se si tiene il ginocchio del bambino in estensione, il piede arriva soltanto ad angolo retto durante la flessione dorsale, non riuscendo a piegarsi di più verso la tibia.
In questi casi si parla di “andatura sulle punte abituale“, e tale forma va distinta, in genere con un semplice esame clinico, da tutte le altre rare condizioni in cui un bambino cammina sulla punta dei piedi ( condizioni patologiche) Ma mentre un bambino che cammina abitualmente sulle punte è in grado, quando vuole, di appoggiare tutta la pianta del piede e quindi anche il calcagno, un paziente con una patologia importante non è sicuramente in grado di camminare in tal modo. Per risolvere tale andatura è utile eseguire esercizi di stretching (cioè di allungamento) del tricipite surale.
CAMMINA CON I PIEDI IN FUORI ” A PAPERA”
Molti genitori si preoccupano in modo non giustificato quando, all’inizio della deambulazione, il bambino cammina male, appare incerto, cade spesso, porta i piedi in fuori o in dentro. È necessario sapere che quando un bimbo inizia a camminare, conserva la stazione eretta con difficoltà, allargando le gambe e appiattendo i piedi sul terreno.
È perfettamente normale perciò che il piccolo cammini con un’andatura incerta poiché la deambulazione richiede un notevole sforzo di coordinamento dei movimenti, ed è di comune riscontro che il bebè tenda a camminare con la massima base di appoggio portando uno o tutti e due i piedi in fuori, “a papera”, perché spesso la stabilità è migliore in questa posizione.
L’atteggiamento in fuori, mono o bilaterale, dei piedini sarebbe dovuto alla persistenza della contrattura dei muscoli che ruotano all’esterno la gamba, come conseguenza di una scorretta posizione del feto in utero. Il mantenimento di questo atteggiamento viene inoltre favorito quando si fa assumere al lattante una posizione a pancia in giù quando dorme, con i piedi ruotati all’esterno.
IL PASSO CON IL PIEDE INTRARUOTATO
I bambini normali non camminano come gli adulti.
La muscolatura, gli arti, la conformazione di un bambino non è come quella di un adulto.
Il passo dei bambini è immaturo. Nello stesso tempo essi vogliono camminare veloci come gli adulti. Entro 6 mesi dall’ inizio della deambulazione iniziano anche a fare movimenti di bilanciamento con le braccia durante il cammino e migliorano la lunghezza del passo e la velocità.
I bambini variano ogni loro passo; raramente camminano seguendo una linea retta e spesso ruotano ed ondeggiano poiché sovraccaricano ora più un lato ora più un altro.
Poiché tutti i bimbi camminano con le ginocchia flesse questo può causare una rotazione della tibia e causare una intrarotazione del piede. Quando il ginocchio è esteso (come nel passo dell’adulto) la tibia non può più ruotare sul femore.
E’ dai 3 anni che il passo si normalizza come un adulto.
Il cammino con il/i piede/i in intrarotazione è una condizione molto frequente e la maggior parte dei bambini ne sono affetti.
Un bambino su 10 tra i 2 ed i 5 anni presenta questo inconveniente, la cosa è più frequente nelle femmine.
D: PERCHÉ’ QUESTO AVVIENE?
R: Il femore (che è l’ osso della coscia) presenta in media nei bambini appena nati circa 30° di rotazione ( dovuto alla posizione intrauterina).
Questa rotazione progressivamente diminuisce fino a scomparire generalmente verso l’ età di 7-9 anni.
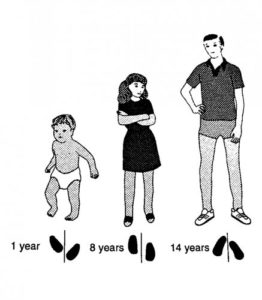
L’andamento del miglioramento può essere quantificato tenendo conto che a 1° anno la rotazione è di 30°;all’ 8° anno 24° di rotazione e a 15 anni 15° di rotazione femorale.
D: PERCHÉ IN ALCUNI BIMBI QUESTO DIFETTO E’ PIÙ EVIDENTE CHE IN ALTRI ?
R: Perché alcuni nascono con una torsione maggiore rispetto ad altri.
Alcuni bimbi invece hanno una rotazione più rigida e non riescono a migliorare.
Altri invece compensano con una extrarotazione della tibia la intrarotazione del femore.
D: E’ VERO CHE A CAUSA DI QUESTO PROBLEMA I BAMBINI CADONO SPESSO ?
R: No assolutamente. La spiegazione delle cadute va solo ricercate nell’ immaturità del passo per i più piccoli.
La torsione femorale fa sì che i piccoli che camminano con una intrarotazione del piede/i abbiano un caratteristico modo di sedere sul pavimento. E’ la cosiddetta posizione a “W” o “Watch position” come detto dagli americani.
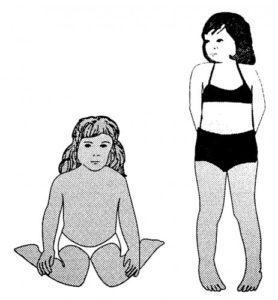
Tale posizione finisce con l’aggravare il problema.
Trattamento
Bisogna innanzi tutto modificare il comportamento di sedersi a terra.
Favorire la posizione seduta “all’ indiana” o altrimenti detta posizione Lotus. Incoraggiare gli sport che fanno procedere i piedi paralleli in avanti (sci, pattinaggio, ginnastica, corsa, etc.)
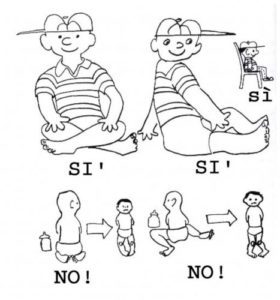
Cercare di correggere l’atteggiamento durante il cammino è controproducente
Apparecchi di correzione non servono
Non usare calzature correttive
LE GINOCCHIA
GINOCCHIO VARO – GINOCCHIO VALGO
Molti bambini quando iniziano a camminare presentano un ginocchio varo.

Successivamente passano ad una fase in cui le ginocchia si presentano valghe.

Per ogni 100 bambini con una alterazione dell’asse degli arti solo 1 o 2 hanno una patologia che necessiterà di trattamento.
Il resto sono varianti della normalità.
Varismo
Quasi sempre associato a torsione tibiale interna
FINO ALL’ETA’ DI 18-24 MESI: nessun trattamento
DOPO I 2 ANNI: se la deviazione non dà segno di progressiva, spontanea correzione sarà il vostro pediatra a valutare cosa fare.
Valgismo

I°: D.I.M. < di 2.5 cm
II°: D.I.M. < di 5 cm
III°: D.I.M. < di 7.5 cm IV°: D.I.M. > di 7.5 cm
(D.I.M. = distanza tra i due malleoli in cm)
SOLO IL 2% DI BAMBINI DI OLTRE 7 ANNI PRESENTA GINOCCHIO VALGO DI IV°
varismo – valgismo
Non è dimostrata l’utilità di tutori, plantari e scarpe ortopediche sia per la correzione del varismo che del valgismo
Se il paziente è sovrappeso, presenta una D.I.C. o D.I.M. >di 8 cm e riferisce dolore alle ginocchia, può essere utile una calzatura o plantare con speronature rispettivamente laterali e mediali
DAL MANUALE DEL PARTECIPANTE
DEL CORSO DI 20 ORE PER IL PERSONALE DELLA MATERNITÀ’ OMS UNICEF 2009
Conservare il latte materno spremuto
Scegliere un contenitore adatto di vetro o di plastica, con coperchio. Lavarlo in acqua calda con sapone e risciacquarlo con abbondante acqua calda e pulita. In caso di spremitura manuale del latte materno, la madre può spremere direttamente nel contenitore.
Se si conservano molti contenitori, ognuno dev’essere etichettato con data. Usare per primo il latte più vecchio.
Il bambino dovrebbe prendere il latte materno spremuto prima possibile dopo la spremitura. Si raccomanda di usare latte materno fresco, piuttosto che congelato.
Il latte congelato può essere scongelato lentamente in un frigorifero ed usato entro 24 ore. Può anche essere scongelato più rapidamente mettendo il contenitore in una pentola o terrina con acqua calda, ma in questo caso bisogna usarlo entro un’ora. Non far bollire il latte materno spremuto né scaldarlo in forno a micro-onde, perché perde le sue proprietà e può ustionare la bocca del bambino.
Conservazione del latte materno
Bambino sano a casa
Latte materno fresco
A 25-37°C per 4 ore.
A 15-25°C per 8 ore.
A meno di 15°C per 24 ore.
Non conservare a più di 37°C.
Refrigerato (2-4°C): fino a 8 giorni.
Mettere il contenitore nella parte più fredda del frigorifero. Molti frigoriferi non mantengono
una temperatura costante. È preferibile usare il latte entro 3-5 giorni o congelare quello che non si userà entro 5 giorni, se c’è un congelatore.
Latte materno congelato
Nel comparto congelatore di un frigorifero: 2 settimane.
Nel comparto congelatore di un frigorifero congelatore: 3 mesi.
In un congelatore separato a bassa temperatura: 6 mesi.
Scongelato lentamente in un frigorifero: 24 ore (non ricongelare), o mettendo il contenitore in una pentola o terrina con acqua calda per uno scongelamento più rapida.
Bambino ammalato in ospedale
Latte materno fresco
A temperatura ambiente (fino a 25°C): 4 ore.
Refrigerato (2-4°C): 48 ore.
Latte materno congelato
Nel comparto congelatore di un frigorifero: 2 settimane.
Nel comparto congelatore di un frigorifero congelatore o in un congelatore separato a bassa
temperatura (-20°C): 3 mesi.
Scongelato lentamente in un frigorifero: 12 ore (non ricongelare).
Estate in salute: come proteggere i vostri bambini

scarica la locandina:
Estate in salute -come proteggere i vostri bambini
Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica
scarica il documento :

Scaricare il documento ” Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni”:
Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
scarica il documento:
GLI OSSIURI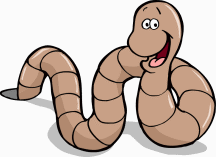
L’infestazione da ossiuri è molto diffusa ed è importante che un genitore sappia riconoscerla
Cosa è un ossiuro?
E’ un piccolo vermicello bianco-trasparente di circa 1 cm, detto anche “Enterobius vermicularis”, che vive esclusivamente nell’intestino umano.
Il bambino, ma anche l’uomo adulto, si infesta ingerendo le microscopiche uova del verme. Queste uova, dopo essersi dischiuse nell’intestino, danno origine in circa 1 mese al verme adulto, la cui femmina depone le uova a livello dell’orifizio anale.
Chi colpisce e come ci si contagia?
L’infestazione colpisce prevalentemente i bambini in età prescolare e scolare (a volte anche 1 bambino su 2!). Questi, dopo avere toccato oggetti contaminati da feci, mettendosi le mani in bocca ingeriscono inavvertitamente le uova del verme che possono sopravvivere nell’ambiente esterno all’intestino anche qualche giorno.
In pratica, quando il verme depone le uova a livello anale il bimbo può avvertire intenso prurito ed è portato a grattarsi il culetto. Piccoli residui di feci attraverso le manine del bimbo possono essere portati agli oggetti con cui viene in contatto: giocattoli, matite, penne, ma anche lenzuola, asciugamani e sanitari. Ed ecco che il “cerchio si chiude”: un altro bimbo toccando gli stessi oggetti e portandosi a sua volta le mani alla bocca viene infestato. Negli adulti l’infestazione è meno probabile, ma non rara.
Che disturbi dà?
Il sintomo più tipico è il prurito a livello anale. Quando si nota che il bimbo si gratta spesso il culetto bisogna insospettirsi. Il prurito si fa di solito più intenso quando il bimbo si corica nel letto la sera. Con un po’ di fortuna il genitore può allora intravedere, aprendo leggermente l’orifizio anale con 2 dita, qualche vermicello che risale velocemente verso l’interno: se si guarda con attenzione non ci si può sbagliare ma bisogna essere rapidi e, appunto, fortunati.
Nelle bambine a volte l’ossiuriasi è responsabile di prurito vulvare e vaginite.
Il fastidio per il prurito si può accompagnare inoltre a irrequietezza e irritabilità: il bimbo appare “diverso” da come era tempo prima e il genitore può non spiegarsi questo cambiamento…
Altri sintomi, fra cui l’ orticaria, sono più rari.
Come si scopre?
Come detto, gli ossiuri si possono anche vedere direttamente: nell’orifizio anale o più raramente nelle feci. Altre volte è necessario ricorrere allo “scotch test”: al mattino, prima che il bimbo evacui e venga lavato, si applica del nastro adesivo per qualche minuto sull’apertura anale. Se è in corso un’infestazione da ossiuri, le uova rimarranno attaccate al nastro adesivo e potranno essere evidenziate al microscopio. E’ un esame di laboratorio semplice ma le uova non sempre si “beccano al primo colpo”. Per essere più certi del risultato bisognerebbe effettuare almeno 3 test, se i primi danno risultato negativo, ma se i sintomi sono chiari il medico può decidere di procedere direttamente alla cura.
Cosa fare?
La cura è semplice ma non è detto che si riesca ad eliminare gli ossiuri in maniera definitiva.
• Esistono farmaci che vanno somministrati in dose unica e ripetuti dopo 2 settimane. Sono tuttavia controindicati nel bimbo sotto l’anno di età.
La cura però non è sufficiente da sola.
• E’ importante infatti impedire l’autoreinfestazione spazzolando con acqua e sapone le manine del bimbo (durante il grattamento alcune uova potrebbero essersi attaccate sotto le unghie) e cambiando la biancheria intima, le lenzuola e gli asciugamani. Come detto le uova possono sopravvivere negli oggetti: in caso di recidive frequenti può essere necessario lavare i giocattoli o sostituire temporaneamente quelli che il bimbo usa più spesso con altri, nell’attesa che le uova muoiano.
• Spesso altri familiari possono essere colpiti dagli ossiuri: nel dubbio si può effettuare lo scotch test o, se il medico lo ritiene opportuno, procedere direttamente alla somministrazione del farmaco a tutti i conviventi. Il farmaco è controindicato in caso di gravidanza per cui le donne in età fertile è bene attendano le mestruazioni prima di assumerlo.
• Altre misure, come abituare il bambino a lavarsi regolarmente le manine e non metterle in bocca, sono naturalmente utili per sè e per gli altri.
Cosa non è necessario fare
Non è necessario l’allontanamento dalla scuola o da altra collettività.
SCOTCH TEST
Attenzione: è preferibile eseguire la ricerca su 3 campioni da raccogliere in tre giorni successivi.
CHE MATERIALE SERVE PER LA RACCOLTA?
- tre vetrini (se richiesti 3 campioni), consegnati dal Laboratorio/Centro Prelievi
- nastro trasparente (scotch).
COME RACCOGLIERE IL CAMPIONE?
- Fare il bidet la sera prima dell’esame, e NON mettere nessuna crema vicino all’ano (zona anale e perianale).
- Il mattino, prima di andare in bagno, prendere un pezzo di scotch TRASPARENTE, e tenendolo ben teso alle estremità con le dita o una palettina di legno (vedi figura A), far aderire perfettamente lo scotch alla mucosa dell’ano ed alla pelle attorno, esercitando una leggera pressione (è meglio farsi aiutare da un familiare). Non sporcare lo scotch con le feci.

- 3. Staccare lo scotch con un gesto deciso e, sempre tenendolo teso, incollarlo a una faccia del vetrino, facendolo aderire bene (vedi figura B)
- 4.Tagliare la parte di scotch sporgente che esce dai bordi del vetrino (NON ripiegarla indietro sull’altra faccia del vetrino!). Avvolgere il vetrino in un pezzo di carta.
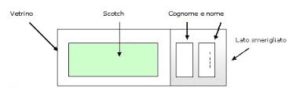
- Lavare bene le mani e le forbici usate per tagliare lo scotch
- 5. Portare il campione (o i tre campioni) al Laboratorio/Centro Prelievi
I campioni dei giorni precedenti vanno conservati a temperatura ambiente.
CHE COS’È.
Per shock anafilattico, o anafilassi, si intende una reazione allergica generalizzata, che si manifesta all’improvviso e che può portare a morte se non prontamente trattata. Inizia con grande rapidità interessando due o più apparati, ad esempio pelle e sistema respiratorio, o circolatorio, o gastrointestinale.
È dovuta all’interazione tra anticorpi IgE e un allergene, sostanza innocua per la maggior parte delle persone, che in pazienti predisposti provoca la produzione di anticorpi IgE
La reazione si può scatenare per l’ingestione di piccolissime quantità di allergene e pertanto non dipende dalla dose: basta una piccola contaminazione di latte, uovo, grano, arachide o altro per determinare una condizione di pericolo in pazienti che hanno forme gravi di allergia.
QUALI SONO LE CAUSE
L’allergene è innocuo quando entra a contatto con l’organismo per la prima volta, ma se entra per la seconda volta a contatto della persona predisposta, incontrerà gli anticorpi IgE fissati sulla superficie delle cellule (basofili e dei mastociti)e questo incontro provocherà il rilascio da parte di queste cellule di grandi quantità di istamina e di mediatori dell’infiammazione.
Sono istamina e mediatori dell’infiammazione i responsabili della grave reazione allergica che porta allo shock anafilattico.
Gli allergeni maggiormente responsabili derivano da:
– Alimenti: latte, uovo, nocciola, arachide, pesce, crostacei, grano, ecc;
– Veleno di imenotteri come ape, vespa, calabrone, giallone;
– Farmaci: penicillina, cefalosporine, FANS, farmaci biologici, ecc;
– Mezzi di contrasto iodato (reazione anafilattoide).
In alcuni casi non si riesce ad identificare la causa scatenante e si parla di anafilassi idiopatica.
COME SI MANIFESTA
Nello shock anafilattico la reazione allergica si manifesta a carico di più organi o apparati. In particolare sono interessati la pelle, le vie respiratorie, l’apparato cardiovascolare, l’apparato gastrointestinale e possono essere presenti sintomi di tipo neurologico.
Nessuno dei sintomi può dirsi caratteristico o esclusivo della anafilassi: ciò che rende il quadro clinico suggestivo è la comparsa immediata, entro pochi minuti, massimo due ore, dal contatto con l’allergene e il rapido, talora esplosivo, affastellarsi di sintomi.
In generale, più breve è l’intervallo di tempo tra il contatto con l’allergene e la comparsa dei sintomi, maggiore è il rischio di una anafilassi grave o talora mortale.
Quando la reazione comincia, di regola si osserva la comparsa di formicolio e senso di calore al capo e alle estremità.
Si manifestano poi, in varia sequenza:
– Orticaria-angioedema;
– Rinite;
– Difficoltà respiratoria;
– Prurito alla lingua e al palato;
– Alterazioni della voce;
– Edema della glottide, rigonfiamento dei tessuti dell’area delle corde vocali che può impedire la respirazione;
– Asma, vomito, diarrea, ipotensione, aumento abnorme della frequenza cardiaca (tachicardia) e aritmia.
COME SI CURA
L’adrenalina rappresenta il farmaco salvavita e deve avere un ruolo centrale nel trattamento acuto dell’anafilassi. Quando è indicata, può essere somministrata a tutti i bambini a qualsiasi età e i genitori dei bambini a rischio di shock anafilattico devono tenere sempre con sé una di queste fiale e non esitare a utilizzarla se compaiono sintomi minacciosi.
I genitori devono essere accuratamente istruiti sull’uso dell’adrenalina con apposito autoiniettore. Questi preparati vanno iniettati al primo segno di reazione allergica, senza aspettare sintomi gravi, per via intramuscolare nella coscia – da 0,2 ml a 0,5 ml a seconda del peso del bambino – e sono disponibili in fiale preconfezionate con adrenalina predosata e resa resistente al calore, stabili per 18 mesi a temperatura ambiente.
Se dopo la somministrazione di adrenalina si ha la risoluzione completa dei sintomi, è comunque importante portare il paziente all’ospedale più vicino dove potrà essere adeguatamente controllato per un periodo che varia dalle 4 alle 6 ore. Se entro 5-10 minuti la sintomatologia non dovesse scomparire, si rende necessario somministrare un’ulteriore dose di adrenalina
Ogni paziente con allergia grave a rischio di vita deve essere dotato di un KIT salvavita (CHENPEN),di un piano d’azione chiaro, deve aver fatto un training educazionale per gestire la terapia dell’emergenza.
La scuola deve essere sempre più coinvolta nella gestione di questi piccoli pazienti con corsi formativi per il personale docente per gestire la somministrazione dei pasti in sicurezza, affrontare le emergenze nell’orario scolastico e durante le attività sportive e culturali, per evitare di escludere questi bambini dagli eventi come gite scolastiche e partecipazioni a tornei sportivi.
La Pediculosi
La pediculosi è un’infestazione causata dalla presenza di pidocchi, piccoli insetti grigio-biancastri senza ali, con il corpo appiattito e le zampe fornite di uncini particolari, che permettono loro di attaccarsi fortemente a capelli e peli in genere; sono forniti, inoltre, di un apparato buccale adatto a perforare la cute e a succhiarne il sangue.
I pidocchi agiscono come parassiti (organismi che vivono “a carico” di altri organismi) e si nutrono pungendo la parte del corpo colpita (cuoio capelluto, corpo o pube), depositando un liquido che causa intenso prurito. Caratteristica fondamentale dei pidocchi è quella di vivere, quasi esclusivamente, sul corpo umano, poiché non possono vivere a lungo lontani dall’ospite.
Il pidocchio, infatti, è un ospite specifico. Gli animali domestici non rappresentano una fonte di trasmissione per l’uomo, così come i pidocchi umani non vengono trasmessi agli animali.
Contrariamente a quanto si tende a credere, i pidocchi “non saltano” da una testa all’altra. Il contagio avviene fra persona e persona, sia per contatto diretto, che attraverso lo scambio di effetti personali quali: pettini, spazzole, fermagli, sciarpe, cappelli, asciugamani, cuscini, biancheria da letto ecc.
Altro pregiudizio è credere che i pidocchi infestino solo le persone sporche. Qualsiasi individuo può essere infestato, indipendentemente dalla sua igiene. Quando c’è un caso in famiglia tutti si dovrebbero controllare a vicenda.
L’infestazione è più frequente nelle scuole, nelle colonie, negli oratori, nelle palestre, in cui vi sono molte occasioni di contatto.
Tra le numerose specie di pidocchi esistenti in natura, quelle che diventano parassiti dell’uomo sono:
- il pidocchio del capo (Pediculus humanus capitis) che causa la maggior parte delle infestazioni.
Di colore grigiastro, spesso si mimetizza con il colore dei capelli dell’ospite.
Di solito si ritrova sulla testa dei bambini e in particolare nelle zone della nuca e dietro le orecchie.
L’insetto è munito di zampette uncinate, che si ancorano ai capelli; il passaggio da un ospite all’altro avviene per contatto diretto del capo o, indirettamente, attraverso lo scambio di effetti personali: cappelli, pettini, sciarpe, cuscini ecc. - il pidocchio del corpo (Pediculus humanus corporis)
Non si distingue, per la forma, da quello del capo, e la diagnosi differenziale si effettua in base alla localizzazione.
Lo si ritrova spesso negli indumenti usati da persone infestate e in questi può sopravvivere anche per un mese.
Anche questo pidocchio si trasmette per contatto diretto, oppure attraverso indumenti e biancheria da letto. - il pidocchio del pube (Phthirus pubis).
Detto anche piattola, per la sua forma schiacciata, è fornito di arti e uncini molto robusti, capaci di ancorarsi a peli più corposi del capello. Si trasmette per contatto intimo, soprattutto negli adulti.Le tre specie sono molto simili tra loro: succhiano il sangue del soggetto che parassitano, vivono su un solo ospite e si sviluppano in stadi successivi:- uova (lendini)
- ninfa (forma immatura del pidocchio)
- pidocchio adulto (in grado di riprodursi).
Le uova sono attaccate alla radice del capello con una loro colla naturale, difficilissima da sciogliere, sono opalescenti, lunghe circa 1 mm e di forma allungata. Le uova vengono deposte 24 o 48 ore dopo l’accoppiamento, a seconda della temperatura più o meno favorevole.
La ninfa rappresenta la forma immatura del parassita adulto; si nutre di sangue da 2 a 5 volte al giorno e diventa adulta, attraverso 3 mute, dopo 7-13 giorni
L’insetto adulto femmina è più grande del maschio; la femmina del pidocchio del capo depone circa 5 uova al giorno, che maturano e si schiudono in 7 giorni, alla temperatura ottimale di 32° C.Gli unici pidocchi in grado di diventare possibili vettori di microrganismi patogeni per l’uomo sono i pidocchi del corpo, che presentano problemi di sanità pubblica nei periodi caratterizzati da calamità naturali o da guerre, in cui sono frequenti situazioni di promiscuità e di disagio sociale.
Quelli del capo, pur rappresentando un problema di sanità pubblica per la rapidità con cui si propaga l’infestazione, coinvolgendo spesso intere classi di alunni, presentano il vantaggio di non poter sopravvivere più di due o tre giorni al di fuori del corpo umano e di essere facilmente attaccati dai vari sistemi di disinfestazione.
Come si manifesta

Le prime punture del pidocchio non si sentono perché nella saliva c’è una sostanza che toglie la sensibilità.
Dopo qualche settimana, la persona inizia a provare prurito locale, avvertendo così la presenza del parassita.
Il prurito è, dapprima, localizzato alle zone di deposizione delle lendini e, in seguito alla nuca e alla parte alta del tronco.
E’ causato da una reazione allergica alla saliva dell’insetto e, pertanto, tra l’infestazione e la comparsa dei sintomi trascorre un periodo di latenza, durante il quale è facile la trasmissione della malattia.Il grattamento può essere causa di lesioni escoriative, impetiginizzazione e ingrossamento locale dei linfonodi.
La diagnosi si basa sull’intensa sintomatologia pruriginosa al capo e sul ritrovamento dell’insetto adulto e delle lendini, specialmente all’altezza della nuca o dietro le orecchie, che appaiono come puntini bianchi o marrone chiaro, di forma allungata, traslucidi, poco più piccoli di una capocchia di spillo.
Si differenziano dalla forfora in quanto le lendini non si staccano dal capello quando lo si fa scorrere tra le dita, essendo tenacemente attaccate ad esso da una particolare sostanza adesiva. La forfora, al contrario, è facilmente asportabile.
Cosa fare La certezza dell’infestazione si ha solo quando si trova il pidocchio vivo, infatti la presenza di lendini non indica di per sé la presenza del pidocchio, né che la lendine sia vitale (ossia, contenente il parassita).
Il miglior sistema di diagnosi, il “wet combing” (pettinare con un pettine a denti fitti, pettine deovulante, tutti i capelli, dalla radice alla punta, dopo averli cosparsi con abbondante balsamo, fino a che non si raccolgono più insetti), è anche un ottima terapia.
Ripetuta ogni 3-4 giorni per 2 settimane da mani esperte, su infestazioni modeste, può essere efficace quanto i tradizionali insetticidi, senza effetti avversi.
Questo sistema consente di stabilire con certezza se ci sono insetti vivi e nel contempo li rimuove, fatto spesso risolutivo nelle piccole infestazioni, che da noi sono le più frequenti. Inoltre consente anche la prevenzione: se si ha notizia di un contatto è facile fare un controllo sul capo del proprio bambino.Per eliminare l’infestazione occorre seguire scrupolosamente alcune indicazioni di trattamento, anche se bisogna dire che nessun prodotto ha effetto preventivo, per cui non si può escludere una successiva reinfestazione.
Ecco in breve cosa fare:
- effettuare un’accurata ispezione del capo, magari con l’aiuto di una lente d’ingrandimento in un ambiente intensamente illuminato, per individuare e rimuovere manualmente pidocchi e uova
- trattare i capelli con un prodotto antiparassitario specifico (sono raccomandati prodotti a base di oli naturali che agiscono “soffocando” i pidocchi)
- dopo il trattamento, usare un pettine possibilmente in acciaio a denti molto fitti, pettine deovulante (i pettini in plastica tendono facilmente a deformarsi), per rimuovere le uova, pettinando accuratamente ciocca per ciocca partendo dalla radice del capello, oppure cercare di sfilarle manualmente; l’eliminazione delle uova è facilitata se si bagna il pettine o meglio la capigliatura con una soluzione al 50% in acqua di aceto, in grado di diminuire l’adesione delle uova al capello
- disinfettare le lenzuola e gli abiti, che vanno lavati in acqua a 60°C o a secco (in particolare i cappelli), oppure lasciare gli abiti all’aria aperta per 48 ore (i pidocchi non sopravvivono a lungo lontani dal cuoio capelluto)
- lasciare all’aria aperta o conservare in un sacchetto di plastica ben chiuso per 2 settimane gli oggetti o i giocattoli venuti a contatto con la persona infestata
- lavare e disinfettare accuratamente pettini, spazzole e fermagli, immergendoli in acqua molto calda per 10-20 minuti (il parassita è sensibile al calore)
- non utilizzare in comune pettini, spazzole, fermagli o cappelli
- in caso di infestazione delle ciglia si può usare un unguento all’ossido di zinco o vaselina; è possibile rimuovere i parassiti e le uova con l’uso di pinzette
I trattamenti In commercio sono disponibili numerosi prodotti contro la pediculosi, sotto forma di polveri, creme, mousse, gel, shampoo, che, in ogni caso, devono essere consigliati dal medico, in grado di prescrivere il trattamento più idoneo.
E’ importante sottolineare che i prodotti contro la pediculosi vanno utilizzati per il trattamento dell’infestazione da pidocchi e non per prevenirla
La riammissione a scuola
La circolare del Ministero della sanità n. 4 del 13 marzo 1998 prevede “restrizioni della frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento di disinfestazione, certificato dal medico curante”.
Se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i pidocchi, il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento.
Qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, dovrà essere disposto l’allontanamento dalla scuola, in modo da interrompere la catena di trasmissione e verrà richiesto un certificato medico di riammissione.
Nel caso in cui il mancato controllo del bambino da parte dei genitori possa legittimamente configurare una carenza della funzione genitoriale, può essere prevista una segnalazione al servizio socio-assistenziale, per i provvedimenti del caso.
Raccomandazioni
Non è possibile prevenire la pediculosi. Usare i prodotti antiparassitari a scopo preventivo non rende immuni dall’infestazione; si tratta di una pratica inutile e dannosa.
E’ possibile, comunque, mettere in atto alcune precauzioni, che sono le sole in grado di poter evitare la trasmissione dei pidocchi e ridurre il rischio di contagio.
Una corretta e mirata informazione e la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti (bambini, genitori, pediatra, operatori scolastici, farmacisti) è già efficace per una prevenzione di primo livello.- educare i bambini ad evitare che i capi di vestiario vengano ammucchiati; soprattutto nelle scuole e nelle palestre sarebbe opportuno che ogni bambino disponesse di un armadietto personale
- educare i bambini ad evitare lo scambio di oggetti personali, quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani
- mettere in atto una sorveglianza accurata, con ispezioni settimanali del capo, in particolare sulla nuca e dietro le orecchie (anche quando il bambino non ha sintomi), sia da parte dei genitori, che del personale sanitario delle scuole, per individuare precocemente il problema
- in caso di infestazione scolastica, nelle famiglie con bambini in età scolare, sottoporre a un controllo sistematico tutti
i familiari, in particolare i figli più piccoli e, alla scoperta di eventuali lendini, applicare in modo scrupoloso le regole
descritte per il trattamento dell’infestazione da pidocchi.
M-CHAT-RTM Checklist ( da compilare a 18 mesi)
Per favore risponda a queste domande tenendo presente qual è il comportamento usuale del suo bambino/a. Se ha visto un certo comportamento alcune volte, ma normalmente il Suo bambino/a non si comporta in quel modo, per favore risponda “No”. Faccia un cerchio intorno a “Sì” o “No” a fianco ad ogni domanda. Grazie molte.
-
Se Lei indica qualcosa che si trova dall’altra parte della stanza, il suo bambino/a guarda da quella parte? (PER ESEMPIO, se Lei indica un giocattolo o un animale, Suo figlio/a guarda verso il giocattolo o l’animale? ) Si No
-
Si è mai domandato/a se il suo bambino/a possa essere sordo/a? Sì No
-
Il suo bambino/a gioca a “far finta che” (gioco di finzione)? (PER ESEMPIO, fa finta di bere da una tazza vuota, o fa finta di parlare al telefono, o fa finta di dar da mangiare ad una bambola o a un peluche?) Sì No
-
Al suo bambino/a piace arrampicarsi sulle cose? (PER ESEMPIO, sui mobili o sugli attrezzi al parcogiochi, o sulle scale?) Si No
-
Il suo bambino/a fa dei movimenti insoliti con le dita davanti agli occhi? (PER ESEMPIO, muove le dita avanti e indietro vicino agli occhi?) Sì No
-
Il suo bambino/a indica con un dito per chiedere qualcosa o per chiedere aiuto? (PER ESEMPIO, indica una merendina o un gioco fuori portata?) Si No
-
Il suo bambino/a indica con un dito per farle vedere qualcosa di interessante?(PER ES., indica un aereoplano in cielo o un grosso camion per strada?) Sì No
-
Il suo bambino/a mostra interesse per gli altri bambini? (PER ESEMPIO, guarda altri bambini, sorride a loro, o va verso di loro?) Si No
-
Il suo bambino/a Le mostra delle cose portandogliele o tenendole in alto per fargliele vedere? Non per chiedere aiuto, ma soltanto per condividere? (PER ESEMPIO, le mostra un fiore, un peluche, o un camion giocattolo?) Si No
-
Il suo bambino/a reagisce quando Lei lo/a chiama per nome? (PER ESEMPIO, quando Lei lo chiama per nome, il suo bambino/a guarda verso di Lei, parla o fa delle sequenze di suoni (come “ba-ba”, “la-la”…) o smette di fare quello che sta facendo?) Sì No
-
Quando Lei sorride al suo bambino/a, lui/lei sorride a sua volta verso di Lei? Sì No
-
Il suo bambino/a è agitato da rumori comuni? (PER ESEMPIO, grida o piange per il rumore di un aspirapolvere o per una musica ad alto volume?) Sì No
-
Il suo bambino/a cammina? Sì No
-
Il suo bambino/a La guarda negli occhi quando Lei gli/le sta parlando, sta giocando con lui/lei, o lo/a sta vestendo? Sì No
-
Il suo bambino/a cerca di copiare ciò che Lei fa? (PER ESEMPIO, La copia quando Lei fa ciao con la mano, batte le mani o fa un rumore buffo?) Si No
-
Se Lei gira la testa per guardare qualcosa, il suo bambino/a si guarda intorno per vedere che cosa Lei sta guardando? Si No
-
Il suo bambino/a cerca di farsi guardare da Lei? (PER ESEMPIO, il suo bambino La guarda per farsi fare un complimento, o dice “Guarda” o “Guardami”?) Sì No
-
Il suo bambino/a capisce quando Lei gli/le dice di fare qualcosa? (PER ESEMPIO, il suo bambino capisce “Metti il libro sulla sedia”, o “Portami la copertina” anche se Lei non indica queste cose?) Sì No
-
Se capita qualcosa di insolito, il suo bambino/a La guarda in faccia per capire come Lei si sente in quel momento? (PER ESEMPIO, se sente un rumore strano o buffo, o se vede un giocattolo nuovo, il suo bambino/a La guarda in faccia?) Sì No
-
Al suo bambino/a piace fare giochi di movimento? (PER ESEMPIO, gli/le piace che lo si faccia dondolare o che lo si faccia rimbalzare sulle ginocchia?) Si No
scarica e stampa il questionario:
m-chat-rtm
Cari genitori, caro/a bambino/a, l’obiettivo della terapia dell’asma è avere un controllo dei sintomi e ridurre il rischio delle riacutizzazioni. Per raggiungere questo importante traguardo è necessario che:
- Il bambino assuma regolarmente lo spray prescritto
- La tecnica inalatoria sia sempre corretta
- Il fumo nuoce non solo a te ma rende più vulnerabile la malattia del bambino, quindi non fumare
- Fare attività fisica , mangiare molta frutta e verdura
- Prevenire l’influenza con la vaccinazione
- Annotare sempre quanto Salbutamolo ha assunto nell’ultimo mese
- Annotare sempre se ha tosse notturna che determina risvegli
- Se ha tosse, difficoltà a respirare dopo attività fisica e se la stessa è limitata
Se l’asma non è controllata ricontatta subito il tuo medico prima di quanto concordato.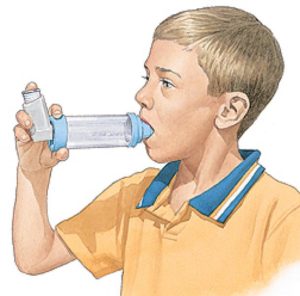
In caso di riacutizzazione:
Salbutamolo spray con distanziatore ( es. Ventolin, Broncovaleas ecc.)
2 puff ogni 10 kg di peso corporeo da ripetere ogni 20’ la prima ora
+
Cortisone
es. bentelan 0,5 mg: 1 cpr ogni 5 kg di peso corporeo da suddividere in 2 dosi, o altro cortisone
(es.prednisone, per bambini con peso>a 20 Kg) come già consigliato dal tuo medico
Importante contattare subito il pediatra e fare visitare il/la bambino/a
In caso di crisi grave : recarsi subito in ospedale o chiamare il 118, somministare nel frattempo Salbutamolo e Cortisone
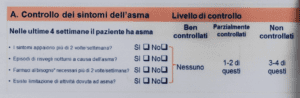
corretto utilizzo del distanziatore:
VISTA
QUESTIONARIO RIVOLTO AI GENITORI PER Il CONTROLLO
DELLA VISTA DEL BAMBINO
(da riportare compilato al controllo del 12″mese)
-segnalare se nella famiglia paterna e materna sono presenti:-persone con difetti visivi prima dei 6 anni SI NO -persone con occhiali prima dei 10 anni SI NO -casi dì strabismo SI NO -casi di gravi malattie agli occhi SI NO -esistono fattori di rischio? SI NO (rosolia prenatale, danni neurologici alla nascita, malformazioni,infezioni meningee o oculari dopo la nascita, traumi cranici o oculari, ossigenoterapia prolungata in periodo neonatale) 1° Mese il piccolo guarda il volto dei genitori? SI NO pensate che la vista di vostro figlio sia normale? SI NO siete preoccupati per gli occhi del bambino? SI NO 3 - 4 mesi segue con gli occhi gli oggetti in movimento? SI NO 6 - 8 mesi è in grado di fissare piccoli oggetti? SI NO 12 mesi siete preoccupati perchè vi sembra strabico? SI NO scarica e stampa il questionario: vista
QUESTIONARIO AI GENITORI PER IL CONTROLLO DELL`UDITO DEL BAMBINO (da riportare compilato al controllo del 12° mese)Cari genitori, i bambini imparano a parlare bene solo se sentono bene. Osservando i progressi che vostro figlio compie via via nell’ascolto, sarà possibile diagnosticare precocemente eventuali danni uditivi e porre rimedio alla sordità. Riteniamo, pertanto, indispensabile la vostra collaborazione di cui anticipatamente vi ringraziamo. segnalare se nella famiglia paterna e materna sono esistiti casi di sordità grave [Sì] [No] 1° mese Esistono fattori di rischio? [Si] [No] (infezioni perinatali,anomalie del cavo orale Iperbiliruninemia superiore ai 20 mg % meningite batterica, asfissia neonatale il bambino si spaventa per i rumori forti? [Sì] [No] ha un pianto stridulo? [Sì] [No] 2 - 3 mesi siete preoccupati per l`udito del bambino? [Sì] [No] reagisce alla voce e ai rumori? [Sì] [No] sorride al suono della voce? [Sì] [No] si ferma attento se gli parlate? [Sì] [No]
ascolta la musica? [Sì] [No] 5 -6 mesi e oltre reagisce al parlare mediante vocalizzi? [Sì] [No] si gira verso la fonte del suono? [Sì] [No] gli piace ascoltare la musica? [Sì] [No] gli piace il suono di un sonaglio? [Sì] [No] pensate che il vostro bambino senta bene? [Sì] [No]
scarica e stampa il questionario:
L’epistassi è la perdita di sangue dal naso; si tratta di un problema ricorrente nei bambini.
Quando si assiste ad una perdita di sangue i genitori spesso si spaventano.
In realtà il sanguinamento dal naso (rinorragia) è un problema clinico che raramente deve preoccupare. La causa più frequente è una debolezza di una piccola regione, denominata Locus Valsalvae, situata nella parte più anteriore del setto. Nella maggioranza dei casi si tratta di una perdita di sangue a partenza da un piccolo vaso venoso (questi sono molto fragili) e il sangue esce a bassa pressione.
Quando il piccolo sanguina dal naso si incontrano genitori molto preoccupati che mettono in atto alcune procedure non sempre corrette.
Fattori predisponenti sono d’inverno un’eccessiva secchezza della mucosa nasale e, in estate, una prolungata esposizione al sole che ha una azione vasodilatatoria (favorisce cioè l’afflusso di sangue). Tutti questi problemi sono inoltre accentuati nei pazienti che soffrono di rinite allergica.
Altre cause, molto meno frequenti, possono essere le malformazioni della struttura interna del naso, i polipi nasali e altri fenomeni proliferativi della mucosa nasale, anomalie della coagulazione, sia congenite (cioè presenti dalla nascita), sia acquisite (ad esempio da farmaci, come l’acido acetilsalicilico) l’ipertensione.
Come si manifesta
Il sanguinamento può avvenire all’improvviso, anche nel sonno. Altre volte può essere scatenato da una soffiata di naso particolarmente vigorosa o dal dito nel naso.
Il sanguinamento può variare da forme molto lievi e di breve durata ad altre molto abbondanti e prolungate, talora richiedenti il tamponamento da parte del medico
Al sanguinamento visibile per la fuoriuscita dalle narici si aggiunge uno scolo di sangue almeno altrettanto abbondante all’indietro; questo sangue, che spesso continua ad uscire anche quando dalle narici l’emorragia sembra essersi arrestata, viene deglutito, e talora vomitato, provocando spesso ulteriore spavento
Una volta verificatasi, spesso l’epistassi tende a ripresentarsi più volte in poco tempo, sia perchè il bambino torna a “stuzzicare” il coagulo appena formatosi, sia perchè il naso viene soffiato poco dopo il primo sanguinamento
Molte volte l’epistassi si ripete sempre dallo stesso lato. Il fatto che si verifichi da ambedue i lati deve sempre indurre a maggiore attenzione, in quanto potrebbe essere spia di una situazione generale (ipertensione, anomalie della coagulazione
Chiamate il medico immediatamente se:

- La pelle presenta macchie emorragiche non causate da traumi
- Il bambino perde inspiegabilmente sangue anche dalla bocca o dalle gengive
- Il bambino è svenuto o ha le vertigini alzandosi in piedi
- La perdita di sangue è stata molto abbondante
- Il bambino sembra stare molto male
Chiamate il medico nelle ore di ambulatorio
- Il bambino ha perso una quantità di sangue considerevole
- Il bambino ha meno di un anno
- Capita spesso che il sanguinamento fatichi ad arrestarsi
- Nella vostra famiglia vi sono o vi sono stati casi di facile sanguinamento
- Avete qualsiasi dubbio o preoccupazione da chiarire
Cosa fare a casa
- Fate stare il bambino seduto e inclinato in avanti, in modo da non deglutire il sangue. Prendete una bacinella, in cui egli possa sputare il sangue che sente in gola.
- Stringete bene, a pinza, tra pollice e indice, le narici del bambino (la parte molle del naso), per almeno 10 minuti. Non mollate la presa fino a che non sono passati i 10 minuti!. Durante questo tempo, dite al bambino di respirare con la bocca, e rassicuratelo.
- Se il sanguinamento non si è fermato dopo 10 minuti, riprovate per altri 10 minuti.
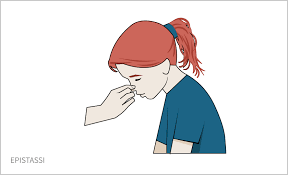
- Chiamate il medico successivamente se:
- anche dopo il secondo tentativo l’epistassi continua
- le epistassi si ripetono tutti i giorni nei giorni successivi nonostante l’applicazione nel naso di vasellina
- avete qualsiasi dubbio o preoccupazione da chiarire
Cosa non fare
- Non applicate panni freddi sulla fronte, sulla nuca o sotto il labbro superiore; non servono.
- Non premete sulla parte ossea, dura, del naso
- Non riempite le narici con alcunchè: nel rimuoverlo, di solito il sanguinamento si ripresenta
- Il sangue deglutito è irritante per lo stomaco. Non agitatevi se succede che il bambino lo vomiti.
- Non somministrate farmaci a base di acido acetilsalicilico: allungano il tempo di sanguinamento, anche per una settimana dopo la loro assunzione
Prevenzione
- Applicate due volte al giorno un po’ di vasellina sulla parete centrale del naso (il setto nasale): serve a ridurre la secchezza e l’irritazione
- Se l’ambiente è troppo secco, e vostro figlio non è allergico agli acari, utilizzate un umidificatore per aumentare il grado di umidità ambientale
- Se il bambino porta spesso le dita al naso, cercate di aiutarlo ad perdere questa abitudine, o almeno a rendersene conto. Fate in modo di mantenergli le unghie corte, tagliandole settimanalmente.
- Evitate la somministrazione di farmaci a base di acido acetilsalicilico: allungano il tempo di sanguinamento, anche per una settimana dopo la loro assunzione.
- Se il bambino ha una rinite allergica, trattarla, ad esempio con un farmaco antiistaminico, potrebbe aiutare a risolvere il problema del sanguinamento
L’ustione o scottatura è una lesione prodotta dal contatto con temperature elevate, come ad esempio fiamme, oggetti roventi, liquidi bollenti oppure attraverso l’azione di radiazioni, come raggi solari, ultravioletti, raggi X , ma anche scariche elettriche, sostanze chimiche ecc.
Le ustioni si distinguono in tre gradi di gravità:
– ustione di primo grado: consiste in un semplice arrossamento dolente della cute. Solitamente guariscono in 5-7 giorni spontaneamente senza lasciare cicatrici
– ustione di secondo grado: vi è interessamento del derma e formazioni di vesciche (flittene). La lesione più superficiale in genere guarisce in 10-15 giorni senza cicatrici, se invece è più profonda la guarigione può essere più lunga e lasciare esiti cicatriziali
– ustione di terzo grado: vi è interessamento dei tessuti ancora più profondi (sottocutaneo) con la morte dei tessuti (necrosi) e formazione di macchie nere e croste. In genere residuano cicatrici evidenti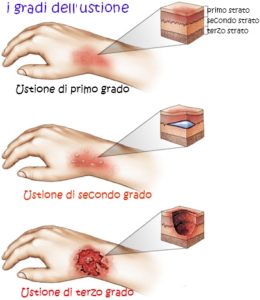
Altri criteri riguardano l’estensione, la sede, e cosa ha provocato l’ustione.
- a) Cosa fare
- Allontanare l’agente ustionante poiché l’ustione è tanto più profonda quanto più a lungo dura il contatto con la fonte di calore. Ciò si attua:
- Spegnendo le fiamme in caso d’incendio degli indumenti Lo spegnimento deve essere seguito poi subito dalla rimozione del vestiario a meno che esso non sia tenacemente attaccato alla cute.
- Rimuovendo subito tutti i vestiti in caso di ustione da liquidi bollenti o da sostanze chimiche liquide.
- Allontanando gli oggetti caldi o roventi e la corrente elettrica dalla cute. Molto spesso la cute sottile e delicata del bambino rimane attaccata alla fonte di calore. In caso di folgorazione, se persiste il contatto con la fonte di energia, il soccorritore non deve toccare il bambino se non è stata tolta la corrente. In alternativa , deve usare del materiale non conduttore.
- Irrigando con acqua corrente in modo prolungato l’area ustionata in caso di ustione chimica dopo aver rimosso i vestiti. Tale manovra deve durare almeno 30 minuti in caso di ustione da acidi e di 60 minuti in quella da alcali.
- Allontanando la vittima dall’ambiente chiuso dove si fosse sviluppato un incendio per impedire la comparsa di lesioni alle vie respiratorie da fumi e vapori bollenti e per impedire l’intossicazione da ossido di carbonio che può essere più pericolosa del calore per la vita dell’infortunato.
- Raffreddare subito tutta l’area ustionata con acqua fredda del rubinetto per circa 20 minuti.
- Ciò riduce il danno che si produce in profondità. Infatti, il processo ustionante si protrae nei tessuti ben più a lungo del tempo di contatto dell’agente termico con la cute. Il raffreddamento può essere attuato anche applicando pezze fredde sull’area ustionata.
- Solo nel caso di ustione estesa il raffreddamento non deve durare più di cinque minuti per non causare una pericolosa ipotermia. Il raffreddamento deve essere effettuato anche se iniziato in ritardo, perché ha ancora efficacia anche se limitata
- Proteggere le aree lese.
- Ciò permette di evitare la contaminazione esterna delle zone ustionate. Può essere attuata con materiale sterile di medicazione o anche, in caso di lesioni estese, mediante l’utilizzo di biancheria pulita. Questa, di più facile reperimento soprattutto in casa, può validamente essere adoperata, basti pensare, per esempio, a quanto è pratico infilare un bambino piccolo dentro una federa di guanciale.
- b) Cosa non fare
- non bucare o asportare le flittene presenti, ciò produce dolore ed espone all’infezione
- non applicare oli, unguenti, creme o altre sostanze empiriche, come per esempio il dentifricio, che possono avere la funzione di lenire più o meno il dolore, ma non quella importante di raffreddare i tessuti, e possono infettare le lesioni
- non applicare il ghiaccio direttamente sulla zona lesa, ma con l’interposizione di un panno pulito e con prudenza per non creare ulteriori lesioni
- non raffreddare più di 5 minuti una lesione molto estesa per non creare un eccessivo raffreddamento corporeo del bambino
Qualora si pensi di condurre il piccolo in Ospedale:
- non applicare antisettici colorati perché essi possono impedire una precisa valutazione delle lesioni
- non applicare pomate o creme antisettiche e antibiotiche che per una precisa valutazione dell’ustione dovranno poi essere rimosse rendendo più lunga e dolorosa la medicazione
La decisione di portare il bambino in ospedale
Non è necessario portare il bambino al Pronto soccorso
La sua medicazione va eseguita sul luogo dell’incidente.
Se l’ustione è molto limitata e non si ritiene necessario portare il bambino al Pronto Soccorso il trattamento consigliato è il seguente:
– dopo aver eseguito il raffreddamento dell’area ustionata lavare la zona lesa con un antisettico non alcolico e, possibilmente, non colorato (va molto bene l’uso del Citrosil che si trova facilmente in casa); applicare una garza non aderente (tipo Connettivina, Fitostimoline e simili) di difficile disponibilità in casa; applicare una pomata antisettica o lenitiva (tipo Foille, Furacin, Argento sulfadiazina) e poi coprire con una garza sterile fissata con cerotti o fascia. Al bambino può essere somministrato un antidolorifico per os o per supposta. Si consiglia di usare il paracetamolo (Tachipirina) che solitamente non manca mai nella casa dove c’è un bambino.
La lesione dovrà poi essere controllata dal medico curante entro i successivi due-tre giorni.
E’ necessario portare il bambino al Pronto soccorso
Va cercato un celere e sicuro trasporto in Ospedale.
Se l’ustione è limitata e l’Ospedale è vicino al luogo dell’incidente, il paziente, una volta protette convenientemente le aree ustionate, può esservi trasportato anche con un mezzo privato.
Qualora l’ustione sia estesa sarebbe opportuno che il bambino fosse trasportato in Ospedale con una ambulanza, meglio con medico a bordo
Per la richiesta di ambulanza è necessario rivolgersi alla centrale operativa del territorio (118).
Cosa fare in attesa dell’arrivo dell’ambulanza
- continuare il raffreddamento dell’area ustionata se non molto estesa
- coprire il resto del corpo del paziente con una coperta
- cessare il raffreddamento dopo i primi 5 minuti in caso di ustione molto estesa e, protette le aree lese, coprire il paziente con una coperta.
Nel caso di ustione chimica, qualora si decida di andare in Ospedale, è molto importante portare con sé un campione del caustico, possibilmente nella sua confezione originale. Ciò serve al medico del Pronto Soccorso per approntare subito il migliore trattamento della lesione.
l

Di cosa si tratta
E’ l’effetto di un colpo al capo, per lo più conseguente ad una caduta (tipica quella del lattante dal fasciatoio o dal lettone!).
Nella maggior parte dei casi le conseguenze si limitano ad una lesione del cuoio capelluto (la parte di pelle coperta dai capelli). Si tratta di una zona molto ricca di vasi sanguigni, per cui traumi anche piccoli provocano facilmente grossi bernoccoli o lividi, o, in caso di tagli, sanguinamenti abbondanti, che richiedono spesso punti di sutura.
La frattura del cranio si verifica solo nell’1-2 % dei casi di trauma cranico e, a meno che si tratti di una frattura scomposta (le ossa fratturate si spostano rispetto alla loro sede originaria), non è indice di maggiore gravità nè motivo per tenere un comportamento particolare; pertanto, l’abitudine di eseguire una radiografia al capo ad ogni bambino con trauma cranico è per lo più di scarsa utilità.
Ancora più rare, ma possibili, le complicazioni interne, che vanno dalla commozione cerebrale (contusione del cervello), all’ematoma (raccolta di sangue in genere tra il cranio e il cervello), all’emorragia cerebrale (emorragia all’interno del cervello).
Non vi è corrispondenza tra gravità delle lesioni esterne e presenza o meno di danni al cervello. Molto più indicativa di conseguenze più serie la presenza invece di determinati sintomi subito dopo il trauma o nelle 48 ore successive.
Di qui l’importanza che i genitori sappiano cosa osservare nel bambino che ha subito un trauma cranico, e in quali casi consultare il medico o il Pronto Soccorso.
Come si manifesta
Di solito la dinamica è evidente, o perchè i genitori erano presenti, o perchè il bambino stesso lo riferisce, o perchè si trova in terra in lacrime un lattante lasciato sul fasciatoio o comunque su un piano più alto. Il cuoio capelluto presenta inoltre le conseguenze del trauma: tagli, abrasioni, lividi, bernoccoli; se il trauma è alla fronte, è frequente il fenomeno degli “occhi neri” a 2-3 gg dal trauma: la pelle intorno agli occhi diventa bluastra per la propagazione verso il basso del livido inizialmente limitato alla fronte. Il bambino accusa inoltre dolore al capo.
Raramente vi è perdita di coscienza, confusione o amnesia (perdita della memoria, in genere relativa al periodo del trauma o immediatamente precedente o successivo); in questo caso si parla di “commozione cerebrale”.
Cosa fare
- Chiamate immediatamente il 118 se il bambino
- ha perso conoscenza
- fa fatica a respirare
- ha subito un trauma al collo
- Chiamate il medico immediatamente se il bambino

- ha meno di 1 anno di vita
- ha un’ampia lacerazione alla pelle o al cuoio capelluto, che continua a sanguinare
- ha subito un trauma particolarmente violento
- dopo il trauma piange continuamente per più di 10 minuti
- presenta convulsioni, perdita di coscienza o confusione mentale
- non riesce a ricordare il momento del trauma
- è molto sonnolento e viene risvegliato con difficoltà
- parla in modo strascicato o comunque ha difficoltà di parola
- ha vomito ripetuto
- ha un mal di testa che peggiora
- vede doppio o è strabico
- non usa un arto o cammina in modo insicuro
- perde sangue o liquido acquoso dal naso o dall’orecchio
- Cosa fare negli altri casi
- Medicate la ferita: lavate le escoriazioni con acqua e sapone, poi comprimete la parte con una garza sterile o un panno pulito per 10 minuti per bloccare il sanguinamento. Applicate ghiaccio in caso di gonfiore.
- Osservate attentamente il comportamento del bambino nelle 24 ore successive al trauma. Particolarmente importanti le prime 8 ore. Dopo le 24 ore trascorse senza problemi il bambino può ritornare a svolgere una vita normale. Per controllare che anche di notte tutto vada bene, controllate il bambino 2 volte, la prima quando andate a letto voi, la seconda 4 ore più tardi: svegliatelo al punto che sia possibile capire se sta bene. Dormite nella stessa camera del bambino, in modo da accorgervi se qualcosa non va.
- Chiamate subito il medico, in questa fase di osservazione dopo il trauma, se il bambino:
- presenta un mal di testa sempre più forte
- vomita ripetutamente
- diventa particolarmente sonnolento o confuso o risvegliabile dal sonno con difficoltà
- parla con difficoltà
- non usa un arto o cammina in modo insicuro
Cosa non fare
- Non date subito da mangiare al bambino: è facile che lo vomiti
- Non somministrate farmaci antidolorifici: se il dolore è tale da richiedere un farmaco, è bene chiamare il medico; altrimenti, il farmaco potrebbe mascherare sintomi che invece dovete tenere d’occhio
- Non svegliate il bambino ad ogni ora della notte: è superfluo e, probabilmente, impossibile
- Non è necessario controllare le pupille del bambino per verificare, come suggerito da qualcuno, se sono di uguale diametro: oltre ad essere una valutazione difficile (soprattutto se il bambino ha gli occhi scuri o è piccolo), è del tutto inutile (in quanto l’anormalità delle pupille è preceduta da altri sintomi meglio identificabili, come confusione mentale e difficoltà a camminare)
Prevenzione
Fuori casa
- In macchina il bambino, a seconda dell’età, deve sedere sull’apposito seggiolino o indossare le cinture di sicurezza.
- Insegnate al bambino a “guardare a destra e a sinistra ” prima di attraversare la strada, e ad usare le strisce pedonali.
- Non lasciate che il bambino esca da soloin bici per la strada finchè (in genere non prima dei 6-7 anni) non è in grado di capire ed osservare le regole del traffico; fategli indossare un caschetto protettivo
- Attenzione a non lasciare da solo un bambino su un carrello al supermercato
- Controllate sempre il bambino mentre gioca nel giardino finchè non ha almeno 4-5 anni
- Attenzione ai tappeti elastici: si possono verificare incidenti anche sotto stretta sorveglianza degli adulti
In casa
- Non lasciate mai da solo un bambino neppure per un istante su un luogo alto, come un tavolo, un fasciatoio, un letto; il bambino potrebbe inaspettatamente rotolare e cadere
- Tenete sempre alte le sponde del lettino. Non appena il bambino mostra di essere in grado di saltare fuori dal lettino, abbassate le sponde
- Se avete letti a castello, non lasciate che bambini piccoli salgano sul letto più alto e usate una sponda di protezione.
- Non usate il girello: oltre che inutile, è pericoloso, per il rischio abbastanza elevato di cadute e perchè con esso il bambino non impara a cadere sviluppando i riflessi di protezione
- Se avete bambini piccoli, sbarrate l’accesso alle scale interne con un cancellino. Quando il bambino è grande abbastanza per salire o scendere le scale da solo, insegnategli ad usare il corrimano
- Usate chiavistelli a prova di bambino per bloccare le porte che fanno accedere in cantina o sulla strada.
- Se vivete ai piani superiori, installate le sicure alle finestre, e non ponete mobili o sedie sotto di esse (per evitare che il bambino si arrampichi)
- Non lasciate il bambino piccolo in custodia al bambino più grandicello, e raccomandate a quest’ultimo di non prenderlo in braccio, soprattutto vicino a finestre o sul balcone
INFEZIONI DELLE PRIME VIE RESPIRATORIE 
ovvero RAFFREDDORE + TOSSE + MAL DI GOLA + FEBBRE
( dura 7 giorni) (14-21 gg) (7 gg) (3-4 gg)
| Come si manifestano? | Naso chiuso e colante, a volte associato a mal di gola e febbre, qualche volta a tosse, raucedine, occhi rossi e ingrossamento delle ghiandole linfatiche del collo. |
| Come si prendono? | I responsabili sono dei virus che interessano naso e gola: questi virus si diffondono da una persona all’altra per mezzo di starnuti, colpi di tosse o con le mani sporche di muco, per contatto con soggetti ammalati o attraverso oggetti contaminati.
I virus dei raffreddori possono sopravvivere sui giochi, asciugamani, telefoni o altri oggetti per tre ore. Dagli oggetti il virus è trasmesso al naso attraverso le mani. Una volta raggiunto il naso i virus cominciano a moltiplicarsi e a diffondersi verso la gola, la trachea e i bronchi, causando mal di gola e tosse. Poiché ci sono circa duecento virus responsabili di queste infezioni, molti bambini sani possono avere più episodi di raffreddore in un anno, specie tra i 2 e i 5 anni. |
| Come si curano? | La cura di queste malattie ancora non esiste.
Infatti gli antibiotici non sono efficaci contro i virus e, se usati comunque, possono favorire le complicazioni da microbi.
|
| Quanto durano? | La durata di questi episodi è in genere limitata, la febbre sparisce in 3-4 giorni, il raffreddore e il mal di gola durano una settimana, la tosse può persistere anche per due, tre settimane.
|
| Come si prevengono? | Evitare il contatto con altri bambini o adulti raffreddati.
Lavare spesso le mani e il volto. Evitare di far soggiornare i bambini in ambienti dove si fuma. |
CHE FARE? 
| Raffreddore
( dura 7 giorni) |
LAVAGGI NASALI |
| Tosse
(dura 14-21 giorni) |
La tosse è il meccanismo con cui l’organismo cerca di portare all’esterno il muco con i virus e i microbi: è quindi da favorire.
Quando è secca e fastidiosa si può aiutare il bambino con vapore acqueo cioè con aerosol di 2-3 ml di soluzione fisiologica per 2-3 volte al giorno per 3-4 giorni e/o umidificando l’ambiente (ad es. accendendo un umidificatore la notte per le prime due ore di sonno). Non è dimostrato che gli sciroppi mucolitici o sedativi della tosse siano efficaci nei bambini; alcune molecole possono dare effetti collaterali E’ efficace il miele che comunque si deve usare solo dopo i 12 mesi. |
| Febbre
(dura 3-4 giorni)
|
La febbre va trattata se è associata a sofferenza del bambino.
I farmaci da usare sono il paracetamolo (Tachipirina o Sanipirina o Efferalgan) o l’ibuprofene (Nureflex o Antalfebal o Sinefev). |
| Inappetenza | In ogni infezione c’è scarso appetito; incoraggiate a bere liquidi, proponete pasti piccoli e frequenti. |
| Mal d’orecchio | Si somministra il paracetamolo (Tachipirina, Efferalgan, Sanipirina ogni 6 ore ) o l’ibuprofene ( Nureflex, Antalfebal, Sinefev ogni 8 ore).
|
| NOTE | I farmaci disponibili per il trattamento delle infezioni respiratorie virali non sono in grado di abbreviarne il decorso né di prevenire le possibili complicanze
|
A cura del suo pediatra e dei medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Salesi
CONSIGLI PER L’ASSISTENZA AL NEONATO SANO 
L’adattamento e il benessere del bambino sono favoriti dalla vicinanza con la madre, dalla buona relazione con lei e dall’allattamento al seno.
Calo ponderale
Nei primi giorni di vita il neonato può diminuire di peso (fino al 10%); con l’allattamento al seno precoce e a richiesta il peso tende ad aumentare dopo 3-4 giorni e torna ad essere lo stesso della nascita entro i 7-14 giorni.
Il latte sarà sufficiente?
Nei primi giorni di vita è bene pesare il neonato una volta al giorno, nudo, al mattino prima di una poppata, per valutare il calo ponderale e la ripresa del peso. Dopo che è iniziato l’accrescimento sarà sufficiente pesarlo una volta alla settimana per valutare la crescita che sarà di almeno 125 g per settimana.
La doppia pesata ad ogni poppata è inutile e può essere ingannevole (la quantità di latte può oscillare considerevolmente tra una poppata e l’altra).
Il bambino ci informa che si sta alimentando adeguatamente quando:
* bagna almeno sei pannolini al giorno ( dopo che è sopraggiunta la montata lattea)
* è allattato a richiesta;
* si consola, dorme e si sveglia per mangiare.
In caso di importanti problemi nutrizionali spetterà al pediatra la decisione di aggiungere latti diversi dal latte materno.
Attenzione, se il bambino è arrivato a perdere il 10% del peso della nascita va consultato il Pediatra.
La temperatura ambiente
Il bambino non dovrebbe essere troppo vestito; la temperatura dell’ambiente dovrebbe essere intorno ai 20° con adeguata umidità (circa 55%).
Le urine
Il bambino deve fare pipì entro le prime 24 ore e, dopo la montata lattea, almeno 6 volte al giorno.
Le feci
Le prime feci (il meconio) vengono emesse entro le 24 ore di vita del neonato. Poi le feci variano molto di colore (gialle, verdi..), di consistenza e in quantità (1-6 volte al giorno) , in base al tipo di alimentazione e alle condizioni del neonato.
L’ombelico
Il cordone ombelicale si asciuga e cade in modo naturale, senza interventi particolari. E’ sufficiente lavarsi le mani prima di toccare il cordone stesso. Il cordone va tenuto pulito e asciutto con una garza sterile che va cambiata ogni giorno; si consiglia di mantenerlo esterno al pannolino.
Rivolgersi al pediatra quando compaiono segni di infezione (rossore, secrezione di pus..) o quando non cade entro le 4 settimane.
Bagno e igiene della cute
Il neonato può fare il bagno tutti i giorni. I detergenti da usare sono quelli neutri e delicati. Fino a che il moncone ombelicale non è caduto si consigliano le spugnature piuttosto che l’immersione.
La pulizia dei genitali della bambina deve essere praticata partendo dal davanti verso la regione anale. Nei maschi non serve e può essere dannoso “aprire il pisellino” cioè retrarre in modo traumatico il prepuzio sul glande.
Il contatto precoce e prolungato tra madre e neonato, soprattutto il contatto pelle a pelle, favorisce la colonizzazione di germi materni: ciò può proteggere il neonato da infezioni.
Posizione nel sonno e prevenzione della “sindrome della morte in culla”
Purtroppo alcuni bambini ogni anno, improvvisamente , senza apparenti motivi, muoiono nei primi mesi di vita. Si ritiene che i seguenti accorgimenti possono drasticamente ridurre questa sfortunata evenienza:
* far dormire i neonati supini (cioè appoggiati sulla schiena);
* non fumare negli ambienti dove vive il neonato;
* evitare il caldo eccessivo nella stanza del bambino ed evitare di coprirlo troppo.
| ATTREZZATURE ED ATTIVITA’ PER IL LATTANTE
Caratteristiche – vantaggi – svantaggi Servizio di Riabilitazione Funzionale – Az. Ospedaliera Meyer – Firenze
|
||||||
| 1.Cuscino “nanna sicura”
|
Come parte della campagna di educazione sanitaria per ridurre il rischio di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome – Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante), viene consigliato di evitare la posizione prona durante il sonno nel primo anno di vita, specialmente nei primi 6 mesi. Viene indicata la posizione supina. Il cuscino “nanna sicura”, in vendita ad un costo basso, è stato ideato appositamente per fare rimanere il bambino di fianco ed impedirgli quindi di girarsi in posizione prona. Tale ausilio è obbligatorio quando è utile tenere il bambino a dormire sul semi-fianco/fianco per un motivo particolare: neonati sensibili, prematuri, asimmetria cranio-facciale, torcicollo… | |||||
| 2. Marsupio
|
Il marsupio offre indiscutibili vantaggi di comodità e funzionalità per gli spostamenti all’esterno ed ha un importante effetto positivo sul processo di attaccamento.
Scegliendo bene un modello che sostiene bene il bambino piccolo, il suo uso può iniziare subito dalla nascita anche nel prematuro. Non esistono rischi per la colonna vertebrale o di altri tipi. Per il bambino non è naturale la posizione girata all’esterno, per non trasportarlo “sospeso” in estensione nello spazio. La FASCIA è ugualmente funzionale avendo il vantaggio di servire anche per il bambino più grande. |
|||||
| 3.Giochi meccanici
|
(Es. “casa delle api”). I giocattoli meccanici non sono indicati in quanto sono troppo “ripetitivi” ed il neonato ha bisogno di esperienze più creative quando è sveglio (chiacchierare con le persone, osservare l’ambiente di famiglia), non di una “TV neonatale”!
Nella fase successiva, cioè dai 3 ai 6 mesi, inizia la maturazione della coordinazione occhio-mano, dell’afferramento, della manipolazione. Poiché questi oggetti vanno tenuti lontani dalle mani dei bambini perché sono pericolosi a tutte le età (fili deboli, componenti piccoli e fragili), non c’è proprio una fase evolutiva in cui sia indicato per il bambino. |
|||||
| 4. ”Palestra”
|
Per “palestra” intendiamo un telaio dove appendere i giocattoli. Tenere il bambino fermo e “servirgli” i giocattoli è valido solo per una fase brevissima: dai 3 ai 4/5 mesi; gli oggetti di corredo spesso vanno sostituiti con i giocattoli più piccoli, di facile presa ed appesi più bassi al livello delle mani per permettergli di afferrarli e metterli in bocca. Dai 4/5 mesi di età sono indicati giocattoli sciolti per favorire la maturazione della manipolazione e del rotolamento.
Non si dovrebbe offrire ad un bambino di qualsiasi età un oggetto che non possa essere preso liberamente in mano. |
|||||
| 5. Tappeto Gioco
|
Il “tappeto gioco” è un quadrato di stoffa con vari giochi incorporati (specchio, animaletti, ecc.).
E’ troppo piccolo per il bambino che deve muoversi ed i giocattoli incorporati non rispettano i bisogni di manipolazione “creativa”. Sono molto meglio una semplice coperta o un tappeto per terra con oggetti “sciolti” adatti alla manipolazione dinamica e all’esplorazione orale e che invitano il bambino a muoversi per andare a prenderli. |
|||||
| 6. Seggiolina- sdraietta
poltrona auto
|
Nello scegliere il modello della seggiolina vanno considerate, a parte gli aspetti sicurezza e maneggevolezza, caratteristiche come la profondità del sedile e la larghezza dello schienale. Spesso è necessario ridurre la profondità con un piccolo sostegno sotto il sedere; i sostegni laterali al tronco sono indicati per ridurre la larghezza e sostenere bene la schiena. A parte l’utilità per il trasporto, (necessario un modello omologato per l’auto), la seggiolina permette al bambino molto piccolo di stare semi-verticale e di partecipare all’ambiente familiare, in momenti in cui non è possibile tenerlo in braccio (preparazione delle pappe, gemelli, pasti familiari). | |||||
| 7. Passeggino
|
Un uso precoce del passeggino (dai 3 mesi) soddisfa il bisogno del bambino, anche piccolo, di seguire le varie attività intorno a sé, di esercitare la vista a distanze diverse e quindi di arricchire le sue esperienze sensoriali e relazionali.
Vanno curati alcuni dettagli per garantire l’allineamento della colonna vertebrale ma soprattutto la stabilizzazione posturo-motoria: utilizzo dei sostegni laterali al tronco. Da ricordare che l’uso dello zaino è possibile solo dopo gli 8 mesi in poi quando il bambino ha un buon controllo del tronco. |
|||||
| 8. Seggiolone
|
Il seggiolone è uno strumento funzionale, che promuove l’interazione bambino-famiglia. Per la sicurezza, bisogna fare attenzione alla scelta del modello, chiudere la cintura di sicurezza e garantire la presenza di un adulto durante l’uso. Impiegando un apposito riduttore e per periodi di tempo brevi, può essere usato fin dai 5/6 mesi. Per consumare i pasti nel seggiolone, è bene aspettare finché il bambino non controlla bene il tronco (7 mesi circa, se non ha lo schienale inclinabile). | |||||
| 9. Box
|
Non viene consigliato l’uso del box perché lo spazio a disposizione è troppo piccolo per un bambino che deve imparare a muoversi. Le ragioni di sicurezza addotte per il suo utilizzo non valgono molto perché comunque la casa va resa sicura per il bambino quando cammina, pertanto è solo questione di anticipare i tempi. Ai genitori è utile introdurre il concetto di una stanza “box” o, meglio ancora, creare una casa “a misura del bambino che gattona e poi cammina”. Il bambino dall’età di 4/5 mesi ha bisogno di stare libero per terra per conoscere lo spazio aperto e di utilizzare le esperienze per maturare le sue abilità e per preparare bene le basi che servono ad alzarsi in piedi e camminare in sicurezza.
Questo bambino è sicuramente più ricco dal punto di vista psicomotorio e più in sintonia con se stesso e l’ambiente in cui vive (conosce i propri limiti e le proprie possibilità) |
|||||
| 10. Girello
|
Il girello non va usato: non rispetta e non favorisce le reali capacità motorie del bambino e può ritardare il bambino nel camminare da solo. Ha un’influenza negativa sulla motricità: ostacola lo sviluppo delle reazioni di equilibrio, del saper cadere e nella conoscenza dei propri limiti; inoltre provoca la tendenza dell’irrigidimento sulle punte dei piedi.
Per gli stessi motivi va sconsigliato l’uso del “jumper” (un’imbracatura attaccata ad un supporto elastico dove il bambino fa dei salti). |
|||||
ATTREZZATURE ED ATTIVITA’ PER IL LATTANTE 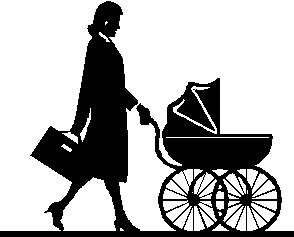
Consigli in relazione ai bisogni psicomotori nelle varie fasi di sviluppo . Servizio di Riabilitazione Funzionale – Az. Ospedaliera Meyer – Firenze
|
…E LA TELEVISIONE ?
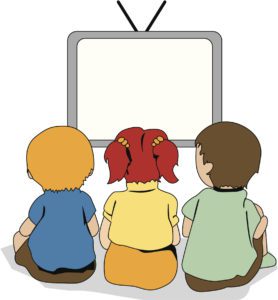
Watching TV
Sempre più spesso ai convegni di aggiornamento per i pediatri e sui giornali si parla dell’influenza che l’eccessiva esposizione alla televisione ha sui bambini. I dati sono sempre più allarmanti: il 90% dei bambini italiani dai 4 ai 14 anni guarda la Tv, in media, 3 ore al giorno. La TV è diventata un “polo relazionale” che, insieme ai genitori e alla scuola, contribuisce in modo determinante all’educazione dei nostri figli.
Come pediatra dei vostri figli vorrei comunicarvi alcuni motivi di preoccupazione per la salute fisica e psichica del bambino che guarda troppo la Tv, e alcuni consigli per un uso corretto di questo strumento.
Il primo rischio è l’invito alla PASSIVITÀ’: la TV dà spiegazioni a tutto e non stimola il b.no a cercarle da solo; in TV si vedono altri risolvere i conflitti, non ci si abitua ad affrontarli personalmente.
La TV DISTOGLIE DALLA REALTÀ’ (gli altri ragazzi, i genitori, gli adulti) in un’età in cui la sperimentazione individuale è essenziale: le regole della convivenza si imparano dalle relazioni e dagli scambi interpersonali con gli amici e gli adulti.
Dalla TV si ha l’idea che la VIOLENZA sia il modo normale di risolvere i problemi (nel 50% delle ore davanti alla TV si vedono spettacoli violenti!).
In TV tutto è presente, mancano il passato e il futuro: in questo modo si condizionano pesantemente la MEMORIA e la capacità di PROGETTARE dei b.ni.
La TV dice che cosa si deve MANGIARE e crea forti squilibri della dieta (l’obesità è in progressivo aumento tra i ragazzi).
La TV espropria del TEMPO LIBERO come tempo da gestire in modo creativo: i
b.ni non conoscono più i tanti giochi dell’era pre-TV!
In TV tutto è spettacolo e il b.no impara a concedere un’ATTENZIONE BREVE e discontinua a tutto (insegnanti compresi!).
QUALI CONSIGLI PER UN CORRETTO USO DELLA TV?
1 – La TV è PREZIOSA per la crescita culturale e per il divertimento dei nostri figli: usiamola bene!
2 – Noi genitori abbiamo il compito di insegnare ai nostri figli il modo migliore di usare la TV!
3 – Offrire della ALTERNATIVE alla TV: gioco, sport, fare musica, lettura..
4 – LIMITARE la visione della TV ad UN’ORA AL GIORNO: oltre questo tempo il b.no non riesce ad elaborare i programmi che vede.
5 – PARLARE sistematicamente con i figli DEI PROGRAMMI VISTI in TV.
6 – SCEGLIERE INSIEME ai figli i programmi da vedere.
7 – GUARDARE LA TV INSIEME ai figli; in questo modo possiamo dare risposte alle domande che i nostri figli si pongono su ciò che vedono.
8 – “SMONTARE” la TV cioè scoprire come si fanno i programmi e perché: ci si può aiutare con dei libri e con le insegnanti di scuola!
9 – MANGIARE CON LA TV SPENTA!
10 – EVITARE la TV in CAMERA dei figli!
Telefoni cellulari e salute dei bambini 
La telefonia cellulare e gli altri sistemi di comunicazione senza filo si basano sulla trasmissione di segnali attraverso onde elettromagnetiche. Nella vita quotidiana tutti siamo esposti a campi elettromagnetici, generati dai telefonini, ma anche da altri dispositivi, quali le stazioni radio base. Date le distanze, le esposizioni dovute a queste ultime sono generalmente bassissime ed inferiori ai limiti raccomandati. Quelle derivanti dall’uso del telefonino, anche a causa della vicinanza al corpo, sono molto più elevate. Ma non preoccupa solo l’intensità dell’esposizione, quanto la durata della stessa: diversi studi hanno confermato la capacità dei campi elettromagnetici di produrre, anche a bassa intensità, una serie di effetti biologici.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha di recente classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibili cancerogeni per l’uomo, tuttavia le Società Scientifiche ancora non hanno elementi che dimostrino con certezza questo legame.
In particolare per i bambini, le incertezze sono tante:
– gli standard di sicurezza vigenti, relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici, sono stati elaborati con riferimento alle persone adulte;
– gli studi finora condotti hanno riguardato periodi di tempo inferiori a quelli dell’induzione di alcuni tumori;
– l’organismo dei bambini è più sensibile rispetto a quello degli adulti;
– il cervello dei bambini ha una maggiore conducibilità, ha una minore consistenza delle componenti ossee ed essendo più piccolo, è ridotta anche la distanza rispetto all’antenna: pertanto l’assorbimento di energia elettromagnetica all’interno della testa di un bambino è superiore rispetto a quanto si verifica nell’adulto;
– il cervello dei bambini soffre in misura più marcata dell’effetto cumulativo delle diverse fonti inquinanti;
– I bambini finiranno per utilizzare il cellulare per un tempo più lungo rispetto all’attuale popolazione adulta.
Perciò, in attesa di ulteriori studi, è doveroso diffondere alcune raccomandazioni, tra le quali la principale è quella di evitare di dare il cellulare ai bambini.
Per coloro che, invece, devono utilizzare il cellulare, è opportuna l’adozione di alcune cautele:
- usare preferibilmente il telefono col filo, evitando i cordless, e comunque non abusare del telefono cellulare;
• usare l’auricolare, preferendo quello col filo al bluetooth;
• fare telefonate brevi, soprattutto se la linea è disturbata ed il telefono è costretto a lavorare a piena potenza;
• evitarne l’uso in ambienti stretti e affollati (cabine ascensori, aerei, auto, ecc);
• non tenere il cellulare a stretto contatto col corpo in fase di ricezione e, quando la telefonata si prolunga, cambiare orecchio;
• tenerlo lontano dal corpo quando si compone il numero e non rispondere immediatamente (in fase di iniziale collegamento con la stazione radio-base i valori sono molto più elevati);
• nell’acquisto dell’apparecchio, preferire telefonini a basso SAR (rateo di assorbimento specifico).
A cura della responsabile SIP per l’Ambiente Maria Grazia Sapia
in collaborazione con la Commissione Ambiente SIP (sett 2011)
 Comunità Amica dei Bambini Ancona
Comunità Amica dei Bambini Ancona
Protocollo Alimentazione complementare ( Divezzamento)
DEFINIZIONE
Con il termine di alimentazione complementare o di svezzamento si intende l’introduzione nella dieta del lattante di nutrienti diversi dal latte sia esso materno o artificiale.
Tale integrazione si rende necessaria per motivi di tipo nutrizionale (aumento del fabbisogno calorico, di ferro e vitamine, di proteine diverse) ma anche per garantire al lattante esperienze alimentari (di gusto, consistenza, formato e modalità di assunzione) differenti dall’alimentazione esclusivamente liquida del solo latte. Integrazioni necessarie quindi per garantire una crescita ottimale sia ponderale ma anche neuro-sensoriale.
ETA’ DI INIZIO
Molte società scientifiche di area pediatrica e organizzazioni internazionali che si occupano della salute infantile hanno emanato delle raccomandazioni sulle modalità più opportune per garantire al lattante i giusti fabbisogni ed al tempo giusto. Purtroppo tali raccomandazioni non sono completamente uniformi e generano talvolta qualche imbarazzo negli operatori che si confrontano con i genitori in questo passaggio importante del 1° anno di vita del bambino.
C’e consenso nel definire l’allattamento materno al seno come la miglior modalità per alimentare il bambino e nel considerare il latte artificiale come un’alternativa possibile solo in assenza documentata di latte materno. Il latte materno è ritenuto unanimemente un alimento completo e sufficiente a soddisfare i fabbisogni nutrizionali del bambino in maniera esclusiva fino all’età di 6 mesi compiuti. Unanimemente si raccomanda di proseguire con l’allattamento al seno a richiesta ed in modo complementare (cioè in associazione con altri alimenti ) anche oltre i 6 mesi, fino a 2 anni e oltre, se mamma e bambino lo desiderano.
Da un punto di vista nutrizionale non vi è alcuna necessità a somministrare nuovi alimenti prima del 4° mese di vita compiuto. E’ possibile iniziare l’introduzione di cibi solidi o semisolidi tra il 4°- 6° mese qualora se ne ravvisi la necessità, con la consapevolezza che un divezzamento precoce può interferire negativamente sul proseguimento dell’allattamento al seno.
Probabilmente la raccomandazione più corretta è quella di personalizzare l’inizio dello svezzamento in base alle caratteristiche di crescita (di peso e neuro-motorie) del bambino e di tener conto anche delle esigenze dei genitori (ritorno all’attività lavorativa della madre, abitudini alimentari e culturali diverse).
E’ consigliabile evitare indicazioni troppo rigide sul momento nel quale introdurre i cibi solidi, stimolando invece i genitori ad individuare autonomamente il periodo migliore per il loro bambino.
Ogni bambino è diverso, ma ci sono 3 chiari segnali che, insieme, mostrano che il bambino è pronto per gli alimenti solidi:
- riesce a stare seduto e a tenere la testa dritta;
- riesce a coordinare occhi, mani e bocca, cioè può guardare il cibo, prenderlo e portarlo alla bocca da solo;
- riesce a deglutire il cibo proposto con il cucchiaino.
Inoltre, altri due segnali importanti sono:
- mostra interesse verso il cibo degli adulti;
- sa far capire con i suoi gesti quando ha fame e quando è sazio (apre la bocca verso il cucchiaio quando ha fame, chiude la bocca e gira la testa di lato quando è sazio).
NOTA
Non tutti sono in accordo nel fissare una data rigida (6 mesi compiuti) al di sotto della quale è sconsigliato somministrare al bambino cibi diversi dal latte. Alcune recenti raccomandazioni, non ancora accettate dalle principali società scientifiche, considerano vantaggioso sottoporre al bambino altri alimenti oltre al latte a partire dall’età di 17 settimane per sfruttare al meglio la capacità di tolleranza di nuovi alimenti che alcuni studi recenti individuano nella fascia temporale compresa tra le 17 e le 26 settimane di vita. Il singolo pediatra valuterà, in base alla forte familiarità per atopia, se anticipare piccoli assaggi di cibi solidi.
COME?
Anche sulle modalità di preparazione e somministrazione del cibo è utile evitare indicazioni troppo rigide e schematiche, favorendo nei genitori l’impiego delle loro tradizioni/abitudini alimentari e l’osservazione delle preferenze del bambino; in questo modo l’introduzione dei cibi nuovi potrà avvenire in maniera personalizzata, favorendo nel bambino l’educazione al gusto in sintonia col quella del nucleo familiare.
E’ possibile sostituire un intera poppata con un pasto solido completo, oppure affiancare al pasto di latte piccole quantità di alimenti solidi o semisolidi (uno – due cucchiai/die), offrendo in questo modo con gradualità un nuovo pasto.
Molti consigliano di condividere con i piccoli gli stessi alimenti dei genitori, adeguatamente spezzettati. Ovviamente questa è una occasione privilegiata per il pediatra per fornire informazioni su una alimentazione corretta per tutta la famiglia, dalla quale dipenderanno le abitudini future dei bambini.
E’ opportuno offrire alcune indicazioni pratiche ai genitori:
-la frutta è a tutti gli effetti un alimento e come tale rappresentare già una forma iniziale di divezzamento; non esistono al momento dimostrazioni scientifiche che indicano l’utilità di somministrare frutta nei primi mesi di vita. E’ utile inoltre considerare lo scarso potere nutritivo di questo alimento che non può pertanto sostituire una poppata.
-quando il bambino non è ancora capace di deglutire in maniera efficace, il cibo viene spinto in avanti dalla lingua piuttosto che indietro: i genitori non informati potrebbero interpretare questo comportamento come un rifiuto del cibo o addirittura come una forma di intolleranza alimentare.
-eccesso di sale e zuccheri semplici non dovrebbero essere aggiunti agli alimenti sia per motivi nutrizionali sia per evitare di condizionare il gusto del bambino; anche le bevande dolcificate, oltre a favorire le carie, possono interferire sull’educazione al gusto.
– è opportuno introdurre gradualmente nuovi alimenti sia per poter osservare possibili reazioni di intolleranza a quel particolare alimento sia per abituare il lattante ad un nuovo gusto.
-non è utile insistere per forzare l’accettazione di un determinato alimento se questo non è gradito: quello che il bambino non vuole oggi, può essere accettato un altro giorno.
-è utile informare i genitori per assicurare una adeguata nutrizione in quanto un eccesso di calorie a questa età può facilitare l’insorgenza nell’età successiva di malattie come l’obesità.
-occorre sempre rispettare l’appetito del bambino, cercando di interpretare il suo comportamento.
-è meglio evitare di prescrivere una quantità precisa di un dato alimento. Il timore è che il genitore interpreti il suggerimento alla lettera insistendo ad offrire cibo anche quando il bambino è sazio, pensando che l’apporto nutritivo sia insufficiente; il bambino che mangia quantità ridotte di pappa, compenserà le proprie necessità attraverso l’allattamento.
-uno schema rigido (riguardo alla quantità e alla scelta degli alimenti) rischia di favorire nel genitore una stretta osservanza allo schema stesso impedendogli di osservare correttamente i segnali comportamentali del bambino (vero indicatore della adeguatezza qualitativa e quantitativa del cibo offerto).
-bisogna evitare che il cibo semisolido venga somministrato attraverso il biberon; questa pratica, oltre ad impedire al bambino di imparare a mangiare da solo, provoca un’inutile confusione tra l’azione del deglutire e quella del succhiare. Chi non è in grado di mangiare con il cucchiaino, non è pronto per lo svezzamento.
-la sequenza di introduzione non è critica; non è necessario iniziare con un alimento piuttosto che con un altro. Si può lasciare libertà al genitore di gestire autonomamente la sequenza dei nuovi alimenti da introdurre in base alla propria esperienza, abitudine e cultura. E’ invece necessario raccomandare di variare gli alimenti per avere una corretta distribuzione di carboidrati, proteine e lipidi.
-la pappa unica (comoda nella preparazione e nella somministrazione) non è l’unica modalità utilizzabile: le portate separate possono offrire una esperienza gustativa molto coinvolgente per il bambino e favorire l’uso delle mani per portare il cibo in bocca.
-è molto importante che il bambino possa toccare il cibo, portandoselo alla bocca da solo con le mani o usando il cucchiaino; anche l’uso del bicchiere o della tazza andrebbe incentivato prima possibile.
-anche per un bambino piccolo il pasto deve rappresentare una attività piacevole e interessante; per questo il cibo dovrebbe avere colore, odore e sapore gradevole e stimolante. Un menù vario, oltre ad essere meglio accettato, favorisce l’educazione al gusto.
-per le famiglie provenienti da Paesi con abitudini alimentari molto diverse dalle nostre, è opportuno incentivare l’uso di cibi tradizionali, considerando che negli anni successivi il bambino assumerà i cibi della propria famiglia.
Riferimenti bibliografici
Agostoni C., Decsi T., Fewtrell M., Goulet O., Kolacek S., Koletzko B. et al. (2008)
Complementary feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 46, 99–110.
American Academy of Pediatrics. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012;129:e827–41.
Azienda Unità Sanitaria di Reggio Emilia -Dipartimento di Cure Primarie – Distretto di Montecchio Emilia. Alimentazione Complementare nel primo anno di vita. (2005) http://www.ausl.re.it/Home/DocumentViewer.aspx?TIPODOC=IAP&ID=988
Claudia Carletti, Paola Pani, Adriano Cattaneo
Alimentazione complementare con un po’ di sale in zucca
Medico e Bambino 2012;31:35-37
|
Volta, A. Fabbri, I. Dall’asta, Z. Guennouna, A. Chiarenza, L. Bonvicini, L. Moscara, D. Pini, C. Ventura Symon B, Bammann M Feeding in the first year of life – emerging benefits of introducing complementary solids from 4 months. Aust Fam Physician. 2012 Apr;41(4):226-9. |
WHO (2002) Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. WHO: Geneva.
WHO (2011) Exclusive Breastfeeding for Six Months Best for Babies Everywhere. WHO: Geneva.
LA CURA DEL PREPUZIO ……. Linee guida per i genitori 
Come si presenta il pisello del neonato?
Il 96% dei neonati presenta un prepuzio non retraibile. Questa condizione è del tutto fisiologica, anzi protettiva per la delicata cute del glande altrimenti a contatto con feci e urina; essa tenderà a risolversi in modo del tutto spontaneo e completo negli anni successivi. A 5 anni solo il 10% dei bambini presenta aderenze.
E’ utile anticipare questo processo con la cosiddetta “ginnastica prepuziale”?
Dal momento che le aderenze fisiologiche proteggono il glande da traumi, infezioni, irritazioni “da pannolino” non è affatto utile accelerare il processo di scollamento. Ogni tentativo di scopertura forzata oltre che doloroso può risultare pericoloso perché causa lacerazioni della cute prepuziale, sanguinamenti ed esiti cicatriziali ben più tenaci delle aderenze fisiologiche
Cosa è utile fare?
Una appropriata detersione esterna dei genitali è fondamentale perché riduce l’incidenza di infezioni e successive aderenze. Usare detergenti liquidi delicati e sciacquare sempre abbondantemente
Sono pericolose le “perle biancastre” molto spesso presenti tra glande e prepuzio ?
Assolutamente no. Queste cisti smegmatiche sono il risultato della normale secrezione genitale; risultano anzi utili in quanto contribuiscono allo scollamento delle aderenze fisiologiche nei primi anni di vita sino alla pubertà.
Quando deve essere trattata la fimosi?
Mai prima dei 5 anni, tranne quei rari casi in cui il bambino presenta infezioni locali ricorrenti (balano postiti ).
In cosa consiste il trattamento?
La terapia è medica e consiste nel trattamento locale con pomate a base di cortisone. Questo approccio è efficace e sicuro nella maggior parte dei casi , nonché privo di effetti collaterali. Solo nei rari casi di fallimento o recidiva si ricorre alla terapia chirurgica.
Gruppo di Studio
Pediatri Asur 7 – Pronto Soccorso Salesi
LA FEBBRE
(a cura dei pediatri di libera scelta e Pronto soccorso Salesi Ancona) 
- La febbre (temperatura ascellare>37,5°e rettale>38°) è un meccanismo di difesa dell’organismo.
- Il termometro da utilizzare è quello digitale da applicare all’ascella;la misurazione rettale può essere utilizzata sotto l’anno di età
- E’ più di beneficio che di danno in corso di malattia acuta.
- Dopo uno sforzo fisico,dopo i pasti,dopo il bagno o in un ambiente eccessivamente caldo (sotto le coperte ad esempio) la temperatura corporea può aumentare anche di un grado .
- Nella stessa persona sono normali variazioni della temperatura corporea nell’arco della giornata.
- Se ha la febbre un lattante sotto i sei mesi : contattare il pediatra appena possibile.
- Se ha la febbre il bambino piu’ grande, in buone condizioni generali e senza sintomi gravi: aspettare alcuni giorni somministrando liquidi e antipiretici al bisogno.
- Non utilizzare gli antipiretici con il solo scopo di ridurre la temperatura corporea; gli antipiretici non prevengono le convulsioni febbrili, tuttavia contribuiscono ad alleviare lo stato di sofferenza del bambino.
- I metodi fisici di riduzione della temperatura (spugnature,bagni tiepidi) sono sconsigliati. Sono utili solo nell’ipertermia(cioè nell’aumento della temperatura indotto da cause esterne, come nel colpo di calore)
- E’ meglio evitare di coprire troppo il bambino con febbre per non ostacolare la termodispersione
Quale antipiretico usare? il farmaco di prima scelta è il PARACETAMOLO:
si somministra preferibilmente per via orale
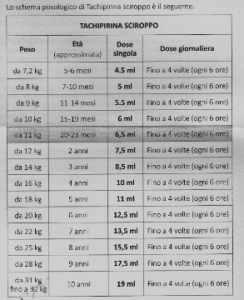
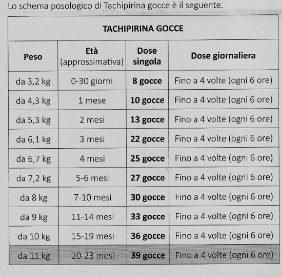
supposte: solo in caso di vomito alla dose di 15 mg per kg di peso corporeo
in alternativa può essere usato l’IBUPROFENE: si somministra alla dose indicativa : peso corporeo : 3 = ml ogni dose, per un massimo di 3 volte al giorno, a stomaco pieno (esempio : un bambino di 15 kg assume 5 ml di sciroppo ogni dose)
non superare mai la dose di 15 ml per somministrazione